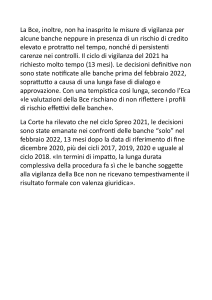Copertina Inizia a leggere Prefazione Coronavirus, il cigno grigio dei mercati Quarta di copertina Lista dei nomi e dei luoghi citati Indice dei contenuti Grazie per aver acquistato l’ebook di Mauro Del Corno La finanza spiegata bene. 11 lezioni di finanza spicciola dall’oro al cigno nero Per ricevere informazioni sulle nuove uscite di Guerini Next Iscriviti alla newsletter Per ricevere informazioni sulle nuove uscite di goWare Iscriviti alla newsletter Oppure vieni sul sito di Guerini Next o di goWare www.guerininext.it www.goware-apps.com Se vuoi contattare l’autore scrivi qui © goWare Via delle Panche 81 – 50141 Firenze www.goware-apps.com e-mail: info@goware-apps.it © 2019 Guerini Next srl via Comelico, 3 – 20135 Milano www.guerininext.it e-mail: info@guerininext.it Prima edizione digitale: aprile 2020 ISBN: 9788868963262 Publisher: Luna Orlando Copertina: Donatella D’Angelo Illustrazione: Stefano Pietramala Sviluppo ePub: Michela Allia Fateci avere i vostri commenti a: info@goware-apps.it Blogger e giornalisti possono richiedere una copia saggio ad Alice Mazzoni – alice@thesis.it e a Giulia Feroleto – ufficiostampa@guerini.it Indice dei contenuti Copertina Frontespizio Colophon Quarta di copertina Prefazione Capitolo 1 – Il mistero del denaro. Che differenza c’è tra una banconota e un pezzo di carta colorato? Addio all’oro, o quasi Soldi dal nulla Alchimisti al lavoro La grande crisi e i suoi postumi Le big five che contano davvero Alla continua ricerca di un equilibrio Perché l’inflazione fa così paura? Capitolo 2 – Bere troppo a una festa tra colleghi e parlare male del capo: come funzionano blockchain e bitcoin Cercatori d’oro digitale Alla ricerca della stabilità perduta Il sogno anti sistema Un’origine avvolta nel mistero 10 anni sulle montagne russe Capitolo 3 – 3,6,3 ovvero cosa fa una banca con i nostri soldi Il «trucco» che fa funzionare le banche Quando si esagera Rincorrere le stelle e cadere nella polvere La corsa agli sportelli Chi paga il conto? Shadow banking,i misteri della finanza ombra Capitolo 4 – Angeli diventati demoni, l’oscura parabola dei derivati Corsa senza freni Assicurazioni letali Contagio attraverso l’Atlantico Italia sull’orlo del baratro Alla bottega dei derivati, prodotti per tutti i gusti e tutte le tasche Quando si gioca con il fuoco, anche i Nobel finiscono per bruciarsi Capitolo 5 – Il mondo alla rovescia dei tassi negativi e l’investitore nel paese delle meraviglie Le ragioni del capovolgimento Il Quantitative Easing, quando una banca centrale si gioca il jolly Il lato oscuro delle politiche ultra espansive delle banche centrali Un piccolo calcolo: valore e rendimento di un’obbligazione O’ spread Curva rendimenti: mito o realtà Capitolo 6 – Di zanzariere, abiti pesanti e capitali: un racconto sulla globalizzazione Tassi alti, un magnete che risucchia dollari da tutto il mondo Il gioco delle valute Fine della festa I piccoli diventano grandi e imparano a difendersi Capitolo 7 – Più ricchi o più poveri? La risposta dell’elefante Sempre meno redistribuzione Tasse? Solo in paradiso Globalizzazione,un biglietto di sola andata? Capitolo 8 – Aziende e bilanci, perché a volte più debiti fai più bravo sei Come è fatto un bilancio L’erba del vicino… Quando si esagera: a lezione giapponese Se a indebitarsi è lo Stato, quando è troppo? Capitolo 9 – Risparmio e investimenti, meglio non da soli (nonostante tutto) Effetto sorpresa Cifre impietose Quanto sappiamo farci male da soli Tra il dire e il fare… Questione di attimi Una borsa per robot e computer? Clamorosi fallimenti del mercato Il menù dell’investitore Capitolo 10 – Verso una nuova crisi? Dimmi perché lo fai Arrivano gli zombies Onestamente, chi può davvero dirlo? Capitolo 11 – Coronavirus, il cigno grigio dei mercati Una reazione da manuale: chi vince e chi perde Materie prime e oro, il piccolo giallo del metallo giallo Investire richiede sangue freddo, cosa fare quando le Borse crollano Letture consigliate Lista dei nomi e dei luoghi citati Quarta di copertina Chi dice che finanza, mercati e investimenti siano materie solo per esperti? Questo libro dimostra il contrario. Senza troppi numeri, con formule al bisogno e un solo grafico, La finanza spiegata bene si concentra sui concetti di fondo, accompagnando il lettore alla scoperta di banche centrali e monete digitali, derivati, borse e quantitative easing, e addentrandosi fino alle conseguenze economico-finanziarie della recente emergenza sanitaria. In 11 brevi capitoli viene descritto e spiegato con stile piacevole, semplice e chiaro il modo in cui funzionano oggi finanza ed economia. Dal mondo alla rovescia dei tassi negativi ai paradossi del debito, dal bilancio di un’azienda al denaro con la sua impalpabile materia prima, dall’oscura parabola dei derivati fino al bitcoin e alle altre criptovalute di cui tanto si parla (e poco si comprende) su Internet e sui giornali. Il libro di Mauro Del Corno contiene nozioni di base che chiunque può e dovrebbe padroneggiare poiché quello che accade in una banca centrale o in una sala investimenti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, influisce, più o meno direttamente, sulla vita di ciascuno. Oggi più che mai. ... Mauro Del Corno è un giornalista finanziario. Dopo essersi occupato dal 2002 al 2019 del programma di Radio 24 «Focus Economia», è ora nella redazione del format televisivo «Sono le venti». Ha scritto per numerose testate, tra cui Il Sole 24 Ore, Investire, Il Fatto Quotidiano. A Valeria e Alessandro Prefazione Da quasi vent’anni mi occupo, come giornalista, di economia e finanza. Nel rapporto con lettori, spettatori e ascoltatori, negli incontri e nei corsi con studenti e colleghi giornalisti, ho sempre notato un grande interesse per argomenti di finanza ed economia che, non di rado, occupano le prime pagine. Per contro, al di là dei corsi di laurea economico-finanziari, il sistema scolastico italiano dedica poco o nessuno spazio a questi argomenti. Con queste pagine, invece, cerco di dare una risposta al desiderio di «saperne di più» che ho riscontrato e raccolto in questi anni. Esistono, è vero, alcuni libri e corsi online dedicati a tali materie, in alcuni casi anche ottimi. Solitamente però sono collocabili ai due opposti estremi: o si tratta di testi pensati per gli addetti ai lavori oppure sono prontuari fin troppo didascalici. Gli undici capitoli di questo libro si focalizzano sugli argomenti economicofinanziari più legati all’attualità, di cui tutti sentiamo parlare. Come funziona una Banca centrale e perché ogni sua decisione può avere un effetto sulla nostra vita? Cos’è il famigerato spread e perché è importante? Andiamo incontro a una nuova crisi finanziaria? Cosa ha provocato quella del 2008? Cosa bisogna sapere prima di investire i propri soldi? Stiamo diventando più ricchi o più poveri? Sono alcune delle domande a cui queste pagine cercano di dare una risposta, nel modo più semplice e chiaro possibile, in modo comprensibile anche per chi con questi argomenti non ha mai avuto a che fare. Dieci capitoli (più uno), pochi numeri, un solo grafico ma una grande attenzione ai concetti di fondo. La speranza è che al termine del libro il lettore sappia destreggiarsi con agilità tra le notizie di economia e finanza, comprendendone appieno il significato, le ragioni e le possibili conseguenze. Capitolo 1 Il mistero del denaro. Che differenza c’è tra una banconota e un pezzo di carta colorato? «Non c’è un uomo su un milione che capisca davvero il denaro.» ( J.M. Keynes) Quando ci si trova nel mezzo di una profonda crisi anche le certezze più consolidate vacillano. Si è obbligati a riflettere sulla natura di ciò che diamo per scontato. Così è capitato durante la crisi finanziaria del 2008, la peggiore del dopoguerra, quando a Wall Street prese a circolare questo arguto indovinello: che differenza c’è tra una banconota e un pezzo di carta colorato? Risposta: l’unica differenza è che Ben Bernanke dice che c’è una differenza. Questa battuta su Bernanke, allora governatore della Federal Reserve (la banca centrale statunitense) è un’affermazione provocatoria eppure acuta, poiché contiene una buona dose di verità. Oggi il denaro non è più collegato a nulla di fisico e tangibile. La sua impalpabile «materia prima» è la fiducia, la convinzione che tutti siano d’accordo riguardo al fatto che con quel pezzo di carta si possano fare acquisti anche se, di per sé, non vale nulla. In passato era diverso. Fino al 1971 rimase in vigore un sistema internazionale denominato «gold standard», in base a cui veniva garantita la convertibilità della moneta in oro: prima in modo diretto, poi attraverso la mediazione del dollaro, con cui le altre valute stabilivano cambi quasi fissi. Una sterlina si poteva cambiare con una determinata quantità di dollari e gli Stati Uniti assicuravano che quei dollari avrebbero potuto trasformarsi in oro sonante. Almeno in teoria, chiunque avrebbe potuto recarsi presso la banca centrale americana e chiedere oro in cambio delle sue banconote. Addio all’oro, o quasi Il gold standard aveva il pregio di assicurare stabilità nel valore delle monete e nei rapporti di cambio. Il difetto era che ne garantiva persino troppa. Il sistema risultò via via troppo rigido per reggere il passo di un’economia in crescita e con scambi internazionali che si moltiplicavano. Gli Stati Uniti, che sovraintendevano a tutto il sistema costruito sulle riserve auree, si trovarono con una bilancia commerciale in passi­vo, ossia acquistavano dall’estero più di quanto vendevano. I dollari che uscivano dal paese erano più di quelli che entravano. Uno squilibrio che si «aggiustava» spostando quantità d’oro da un paese all’altro. Presto si trovarono nell’impossibilità di onorare la garanzia di convertibilità delle monete in oro molto semplicemente perché l’oro non era più in quantità sufficiente. Il legame con il metallo giallo fu quindi rescisso, garantendo al sistema più flessibilità ma anche maggiori fluttuazioni dei cambi. Il valore delle diverse monete non fu più legato quasi soltanto ai fondamentali economici dei paesi che la emettevano, ma anche alle pressioni dei mercati finanziari. Da allora il valore del denaro si regge unicamente su una doppia promessa: che sia accettato da tutti come mezzo di pagamento e che la quantità di beni che si possono comprare con una certa somma non subisca eccessive variazioni nel tempo. Finché ho la certezza di poter spendere i soldi che ho in tasca ovunque voglia, poco importa che, di per sé, quei pezzi di carta non valgano nulla. In tempi normali questo fatto è dato talmente per scontato che neppure ci si pone il problema. A pronunciare questa promessa, e a fare in modo che resti credibile nel tempo, sono le banche centrali. Hanno infatti il compito di preservare il valore della moneta. Come? Principalmente gestendone la quantità in circolazione in un paese o all’interno di un’area valutaria, come quella dell’euro, di cui l’Italia fa parte. Alla stregua di qualsiasi altro bene, anche per la moneta, scarsità o abbondanza ne accrescono o ne riducono il valore. Se la moneta aumenta più dell’incremento dell’attività economica, il suo valore diminuisce (con la stessa banconota posso comprare meno beni rispetto a prima) e i prezzi salgono. Si genera quindi inflazione, la piaga del capitalismo. L’aumento dei prezzi taglia il potere d’acquisto dei salari ed erode i risparmi. Viceversa, in condizioni di scarsità di moneta il denaro «costa molto», chiedere prestiti diventa oneroso e così si investe e si consuma di meno. L’economia non riesce a esprimere tutto il suo potenziale di sviluppo, come se fosse un motore poco lubrificato. Quindi, più una banca centrale si dimostra affidabile nella capacità di calibrare correttamente la quantità di denaro, più l’attendibilità della sua promessa è alta e la moneta che gestisce pregiata. Soldi dal nulla Vediamo ora come fanno le banche centrali a controllare la quantità di moneta. Una banca centrale è una specie di banca delle banche, il posto dove le banche normali tengono i loro depositi. Tecnicamente la creazione di moneta avviene in gran parte all’interno dell’intero sistema bancario. Il denaro ha infatti, prevalentemente, la forma di depositi. Solitamente, i soldi che teniamo sul conto corrente sono molti di più di quelli che abbiamo in tasca o che un’azienda ha in cassa. A maggior ragione oggi che pagamenti, anche modesti, possono effettuarsi con carte elettroniche, altro non fanno che spostare denaro da un conto corrente all’altro. Ogni volta che una banca concede un prestito, non fa altro che mettere a disposizione una somma di denaro sul conto corrente di chi ha chiesto il finanziamento. Per farlo la banca iscrive questa somma tra i «passivi» del suo bilancio, poiché sono soldi che deve a qualcuno. Contemporaneamente, però, il prestito appare anche tra i suoi «attivi», ossia le voci del bilancio che producono guadagni (vedi cap. 3) in quanto il cliente pagherà un interesse. Banca e cliente mettono in atto una promessa contro un’altra promessa: quella di trovare dei soldi a disposizione sul conto e quella di restituirli con una scadenza prefissata. Gli inglesi usano l’espressione money from thin air, soldi dall’aria rarefatta, soldi dal nulla. Sembra un trucco da prestigiatore. Sembra… ma non lo è. La banca «crea» denaro non per sé, ma solo per prestarlo a qualcuno, e nello stesso momento questo qualcuno accende un debito verso la banca. Quando il debito viene ripagato quel denaro, spuntato dal nulla, sparisce di nuovo nel nulla. L’unica traccia che rimane sono gli interessi e le commissioni incassati dalla banca per orchestrare l’operazione. È talmente semplice da sembrare complicato (o viceversa). Una banca non può tuttavia prestare soldi all’infinito. È infatti soggetta a diversi vincoli, interni ed esterni. Ci sono valutazioni di opportunità: fare prestito non è un buon affare se il debitore non è affidabile. Ma, soprattutto, ogni banca è obbligata ad accantonare una quantità di denaro proporzionata ai prestiti che ha in essere per fronteggiare eventuali perdite. Se i prestiti aumentano, anche la riserva deve crescere. Queste riserve sono depositate presso la banca centrale e banche con riserve in eccesso possono prestarne una parte a una banca che si trovi temporaneamente a corto di risorse. Scostamenti momentanei dagli obblighi di riserva sono consentiti, l’importante è che, a fine giornata, tutte le banche siano in regola con i requisiti assegnati. Questi continui spostamenti di denaro, che rendono più flessibile ed efficiente il sistema del credito, avvengono dietro il pagamento di un tasso di interesse deciso dalla banca centrale. Più il tasso è basso più le banche avranno facilità a prestarsi denaro. Viceversa un tasso alto riduce la convenienza di queste operazioni. Con tassi bassi si creano quindi le premesse per aumentare l’elasticità del sistema del credito, le banche riescono a erogare più credito, creando quindi più moneta. Con tassi alti accade il contrario. Questi prestiti tra banche hanno una durata molto corta, a volte di un solo giorno, con eventuali ripetuti rinnovi. Tuttavia, le variazioni del tasso deciso dalla banca centrale si ripercuotono su crediti di qualunque durata, sebbene i prestiti di breve durata risultino i più influenzati. Per questa ragione, ogni volta che una banca centrale muove il suo tasso, la decisione diventa una delle prime notizie di giornali e telegiornali. Avrà infatti effetti sulle rate di qualsiasi prestito a tasso variabile così come sui rendimenti di titoli di Stato e obbligazioni societarie che sono a loro volta dei prestiti. Come un sasso lanciato in uno stagno, agisce in maniera immediata e più forte sui titoli a breve termine ma via via si propaga ai titoli più «lunghi». Ci sono altre leve che una banca centrale può manovrare per dosare la quantità di denaro in circolazione. Può alzare o abbassare il tasso che pratica sui soldi che lei stessa presta alle banche. Oppure accrescere o ridurre la dimensione delle riserve che le banche sono obbligate ad accantonare. Più la soglia si abbassa, più risorse si liberano per concedere crediti e viceversa. Un altro modo utilizzato dalle banche centrali per immettere o drenare liquidità è la compravendita di titoli di Stato con le banche. Se una banca centrale vuole aumentare la liquidità compra titoli di Stato da una banca e «paga» aumentandone la riserva. Vendendo titoli fa il contrario. Alchimisti al lavoro Perché una banca centrale dovrebbe aumentare i tassi e mettere il bastone tra le ruote a banche, aziende e famiglie che hanno bisogno di finanziamenti per acquisti e investimenti? Di nuovo torna utile una battuta. Si dice che il compito delle banche centrali sia portare via le bottiglie degli alcolici quando la festa inizia a scaldarsi troppo. Nei periodi di boom economico la speranza di rapidi guadagni cresce, i cordoni della borsa si allargano e si prestano soldi chiudendo un occhio – o anche entrambi – sull’affidabilità di chi li riceve. Si creano così le premesse per le crisi che non di rado interrompono un periodo di crescita troppo tumultuosa. Sia la Grande Depressione del 1929, sia la Grande Recessione del 2008 sono state precedute da un forte aumento dei debiti delle famiglie. Avrete forse notato che le sedi delle banche hanno spesso architetture imponenti, quasi a modo di fortezze, per infondere un’idea di solidità e ispirare… fiducia. Ripensiamo alla «formula magica» su cui si regge tutto il castello della finanza: fiducia nelle promesse di pagamento, una lunga catena di promesse. Un conto corrente non è altro che una promessa che la banca fa ai suoi depositanti di fornire denaro contante a loro richiesta. Un prestito è la promessa di accedere a un conto corrente. Esiste però una gerarchia. Il denaro vero, le riserve presso la banca centrale stanno in cima, i depositi bancari appena sotto. Via via a scendere tutti gli altri prodotti finanziari che hanno in comune di essere una qualche specie di credito. Nella loro molteplicità di significati le parole contengono verità: credito sono soldi che mi spettano, ma è anche la fiducia che accordo a una persona. Nei periodi di crescita economica tutte le promesse sembrano affidabili. Per ottenere denaro in prestito si danno in pegno, e si accettano titoli di varia natura, anche i più rischiosi. La gerarchia si appiattisce fino a quasi sparire. Ma non sparisce. Così appena la fiducia nella capacità dei debitori di rispettare gli impegni viene scalfita, la dura legge gerarchica riemerge con prepotenza. Credit is suspicion asleep, il credito è sospetto addormentato, disse nel 1981 il membro della Federal Reserve Henry C. Wallich. Quando scoppia una crisi nessuno vuole più prodotti finanziari, tutti cercano sicurezza: moneta sonante, titoli di Stato, oro. Siamo in grado di fare una riflessione in più. Perché l’oro? A pensarci bene è solo un metallo, ha un valore ornamentale, qualche utilizzo industriale, ma non è certo qualcosa di indispensabile o insostituibile. Alla base c’è la stessa convinzione, e convenzione, che regge la moneta, solo consolidata da secoli e quindi ancora più granitica. L’idea che si possa sempre utilizzare l’oro per saldare i debiti e pagare. Resa un poco più concreta dal fatto di tenere in mano una pietra e non carta. Poiché la fascinazione di questa pietra è tutt’altro che estinta, le banche centrali detengono ingenti quantità di oro, anche al fine di diversificare i loro investimenti. La Banca d’Italia conserva nei suoi forzieri di Roma circa 1.200 tonnellate di oro e una quantità più o meno analoga di lingotti italiani è depositata presso le banche centrali di Stati Uniti, Inghilterra e Svizzera. Si tratta della quarta riserva di oro al mondo dopo Usa, Germania e Fondo monetario internazionale. Un libro di qualche anno fa di Neil Irwing, dedicato al ruolo svolto dalle banche centrali nella crisi del 2008, si intitolava non a caso The alchimistes. Ora possiamo però anche cogliere quanto sia illusoria, da un punto di vista finanziario, l’idea degli alchimisti di arricchirsi trasformando altre materie in oro. Se anche fosse possibile tramutare ogni metallo in oro nel momento in cui ci fosse abbondanza di metallo giallo, il suo valore crollerebbe. L’oro è prezioso anche perché è poco. La grande crisi e i suoi postumi La crisi del 2008 è stata talmente acuta e profonda da far temere il collasso dell’intero sistema finanziario globale. Le crisi bancarie si ripercuotono sempre sull’economia reale, le aziende, le famiglie. Per scongiurare questo scenario – e scongiurare una Grande Depressione simile a quella che fece seguito al crack finanziario del 1929 – le banche centrali hanno varato una serie di misure dette «non convenzionali». Molti avranno sentito parlare del quantitative easing, tradotto in italiano con «allentamento quantitativo» (il gergo delle banche centrali è sempre abbastanza «esoterico». Probabilmente si ha l’idea che l’uso di un linguaggio incomprensibile ai più contribuisca ad accrescere l’aura quasi sacerdotale di chi gestisce il denaro). Il «quantitative easing» è semplicemente un’operazione che una banca centrale effettua direttamente sui mercati acquistando obbligazioni e titoli di Stato (vedi cap. 5). A venderglieli sono soprattutto fondi pensione, banche, assicurazioni. Pagando i titoli con denaro crea­to appositamente, la banca centrale immette moneta sui mercati, facilita il credito e sostiene il valore di azioni e obbligazioni. La speranza è che in questo modo si riesca a dare una spinta all’economia. Purtroppo mentre gli strumenti a disposizione di una banca centrale sono molto efficaci nel frenare un’economia surriscaldata, non si può dire lo stesso quando l’intento è quello di dare un impulso. È un po’ quello che accade con una corda, perfetta per tirare, quasi inutile per spingere. Per quanto una banca centrale si sforzi di mettere a disposizione del denaro, non può costringere aziende e famiglie a chiederlo in prestito per fare investimenti, acquistare case o altri beni. Soprattutto quando le aspettative per il futuro non sono rosee. Le big five che contano davvero Le banche centrali che contano davvero sono cinque. La Federal Reserve statunitense, che regna sul dollaro; la Banca centrale europea per l’euro; la Bank of England con la sua sterlina; la Banca nazionale svizzera per il franco e la Bank of Japan per lo yen. Gestiscono le monete più pregiate del mondo. Gli azionisti delle banche centrali sono spesso banche private ma la loro natura giuridica rimane quella di un soggetto pubblico. La nomina dei vertici compete ai Governi, sebbene una serie di misure ne assicuri poi l’indipendenza del potere esecutivo. Nel corso dei secoli hanno accumulato diverse funzioni. E con il diffondersi delle teorie monetariste il governo della moneta si è affermato come il principale metodo per agire su economia e mercati. Governo della moneta, controllo dell’inflazione, salvaguardia del sistema finanziario, benessere del sistema economico, vigilanza sul sistema bancario, sono tutti compiti demandati alle banche centrali. La Federal Reserve ha nel suo statuto una doppia missione: mantenere l’inflazione su valori ottimali e favorire crescita economica e occupazione. Nel caso della Banca centrale europea è stata accordata una preferenza al controllo dell’inflazione. Il supporto all’economia fa parte dei compiti della Bce ma in subordine rispetto all’azione sull’andamento dei prezzi. Alla continua ricerca di un equilibrio Le banche centrali si occupano anche di tutelare la «loro» moneta sul mercato dei cambi. Per farlo dispongono di ingenti riserve di valuta estera. Se lo yen perde troppo valore nei confronti dell’euro, la Bank of Japan inizierà a vendere sul mercato le sue riserve di euro per comprare yen. Per la legge della domanda e dell’offerta, il valore dello yen salirà mentre quello dell’euro scenderà. Le banche centrali hanno infine il compito di preservare la stabilità del sistema finanziario e creditizio. A tal fine agiscono come «prestatori di ultima istanza». Significa che quando una banca è in difficoltà, la banca centrale può intervenire per salvarla prestando il denaro che le permetta di superare la crisi. Nel 1873 Walter Bagehot, economista e direttore del periodico Economist scrisse Lombard street divenuto una sorta di Antico Testamento delle banche centrali. Nel libro si suggerisce, in caso di crisi, di prestare soldi velocemente, senza limiti ma in cambio di «buoni collaterali» (titoli a garanzia del prestito) e con un tasso di interesse alto. I prestiti dovrebbero però essere concessi solo a banche solventi. Ossia che possiedono asset che superano il valore dei loro debiti, ma che non possono essere venduti abbastanza rapidamente per far fronte alla necessità di denaro. Quello delineato da Bagehot è un ruolo «minimale» delle banche centrali. Nel tempo, e soprattutto dopo la Grande Depressione, i margini di intervento degli istituti centrali si sono ampliati, anche per rispondere alla crescente richiesta di protezioni da parte di quote di popolazione sempre più ampie in possesso di prodotti finanziari e/o finanziamenti bancari. Al giorno d’oggi siamo abituati ad assistere a salvataggi che sono molto lontani dai dettami dell’economista inglese. Spesso assistiamo a interventi a vantaggio di banche chiaramente insolventi, in cui banche centrali e governi accettano di subire delle perdite pur di evitare il dilagare e l’incancrenirsi di una crisi. Se questo sia un bene o un male è argomento di acceso dibattito tra economisti. La recente disciplina del bail-in, da poco introdotta in Europa, riporta l’approccio un poco più vicino all’impostazione originaria di Bagehot. Perché l’inflazione fa così paura? Entro un certo livello (da 2% a 5%, a seconda di varie scuole di pensiero) l’inflazione, ossia il progressivo e generalizzato aumento dei prezzi, è un fenomeno positivo e desiderabile. Un aiuto per l’economia poiché rende più sostenibile il peso dei debiti e fa crescere, seppur solo in apparenza, i ricavi delle aziende. Al contrario quando l’inflazione finisce fuori controllo può abbattere l’economia con la forza di un uragano, disarticolandone tutti i meccanismi di funzionamento. E tutto succede molto in fretta. Gli esempi abbondano. Nella Germania dei primi anni Venti del secolo scorso si registrarono tassi di crescita dei prezzi del 600% e oltre; nel Perù guidato da Antonio Garcia (19851990) l’inflazione raggiunse il 7000%, in Argentina il problema è ricorrente, l’ultimo rapporto di iperinflazione, almeno 40%, risale al 2015. In questi anni l’inflazione del Venezuela è arrivata alla surreale cifra di 10 milioni per cento l’anno. In pratica il prezzo di una pietanza ordinata al ristorante raddoppia mentre la si mangia, lo stipendio ricevuto al mattino non vale più nulla la sera. In altri termini, la moneta rinnega le sue promesse. Non conserva più il valore e, realisticamente, non può essere più utilizzata come strumento per gestire gli scambi. Le cause che portano a queste situazioni sono diverse, ma, almeno negli episodi più recenti, si possono riconoscere alcune dinamiche comuni. Banche centrali fortemente condizionate dal potere politico, stampano moneta per finanziare spese del Governo a deficit. Seguono brevi periodi di boom, con discesa della disoccupazione e aumento dei salari. A questo punto però i prezzi iniziano a correre, le autorità reagiscono tentando di bloccare «per legge» i rincari, senza successo. Alla fine il sistema collassa e l’economia finisce in recessione. Capitolo 2 Bere troppo a una festa tra colleghi e parlare male del capo: come funzionano blockchain e bitcoin Può capitare a tutti di alzare il gomito durante una festa tra colleghi, e così lasciarsi sfuggire qualche considerazione poco rispettosa sui propri superiori. Si suppone che nessuno stia registrando le incaute parole (a meno che si tratti di colleghi davvero perfidi…) e che nessuno sia incaricato di prendere appunti su quanto si sta dicendo. Insomma non esistono prove in mano a un’«autorità di controllo» ufficiale. Però tutti hanno sentito quel che è stato detto: il giudizio negativo sul capo è stato condiviso con i partecipanti. La mattina seguente, sveglio e sobrio, l’autore delle esternazioni si pente, vorrebbe non aver mai pronunciato quelle parole. A quel punto, però, l’unica cosa che potrebbe fare sarebbe di recarsi da ognuno dei colleghi presenti alla festa, modificarne la memoria convincendoli, uno per uno, che il senso delle sue parole era diverso. Più il numero dei partecipanti alla festa aumenta e più l’impresa diventa complicata. Esattamente la stessa logica sta alla base della blockchain, la tecnologia che sostiene il funziona­mento di monete digitali come il bitcoin e che sta trovando applicazione in numerosi altri ambiti. Di per sé il principio dell’informazione condivisa non è nulla di nuovo. Nell’antichità parole pronunciate davanti a un’assemblea erano come scolpite nella pietra, anche quando nessuno provvedeva materialmente a scriverle. Oggi i progressi tecnologici hanno messo a nostra disposizione una spaventosa, e pericolosa, capacità di registrare e accumulare dati. Questo permette anche di estendere il sistema della condivisione di un’informazione su scale infinitamente più grandi rispetto al passato. L’informazione condivisa e decentrata può così essere usata per gestire innumerevoli transazioni, senza che ci sia bisogno di un’autorità terza incaricata di verificare e garantire l’affidabilità degli scambi, validati all’interno della stessa rete dei partecipanti. Due imprese possono per esempio effettuare una compravendita, magari per un valore di decine di milioni di euro, in piena sicurezza e senza pagare commissioni a una banca. Quando un possessore di bitcoin, chiamiamolo Mario, effettua un acquisto, trasferisce delle monete digitali dal suo conto a quello del venditore, chiamiamolo Pietro. Questo passaggio di bitcoin viene comunicato a tutti i computer collegati nella rete blockchain. Quindi «tutti» sanno che Mario ha pagato Pietro. Una volta che l’informazione è recepita, i membri della blockchain la memorizzano e lo scambio viene approvato. Di ogni singolo bitcoin è conosciuto ogni spostamento susseguitosi nel corso del tempo. Si costruisce quindi una catena (chain) di passaggi, di cui si conserva traccia in questo archivio diffuso, pubblico e condiviso. Ogni passaggio aggiunge un nuovo «block», ovvero blocco, alla catena. Tutte le informazioni vengono scambiate attraverso l’uso della crittografia, cioè una scrittura decifrabile solo attraverso un codice. Pertanto, benché tutti sappiano tutto di ogni singolo bitcoin, non si sa praticamente nulla di chi li utilizza. L’identità di ogni utilizzatore è schermata dietro a un codice formato da una trentina di numeri e lettere. In fondo, se il pagamento è reso sicuro dal sistema che lo gestisce, chi vende qualcosa non ha bisogno di sapere nulla di chi compra. Questo ha fatto sì che le monete digitali siano particolarmente attraenti anche per le compravendite di prodotti o servizi illegali, disponibili in abbondanza sul web, e che suscitino una certa diffidenza tra banche centrali e autorità di vigilanza. Cercatori d’oro digitale Di chi sono questi computer che compongono la rete blockchain? Chiunque può entrare a far parte di questo network attraverso l’utilizzo di un pc e appositi programmi, mettendo a disposizione della rete le capacità di calcolo e di memoria del proprio computer. Una volta elaborata una certa quantità di informazioni, si riceve un «premio» sotto forma di bitcoin che si creano nel computer. In gergo si diventa un «miner», ossia un minatore che «scava» filoni di oro virtuale. Più si moltiplicano le transazioni e crescono gli utilizzatori di bitcoin, più la mole di informazioni che questa rete di computer deve gestire aumenta. Servono capacità di calcolo sempre maggiori e diventa più difficile e dispendioso coniare nuove monete. Bisogna «scavare» di più insomma. Il sistema prevede che non possano essere create più di 21 milioni di bitcoin, a oggi ne sono stati creati circa 17 milioni. Il costo dell’energia necessaria per produrre un bitcoin rischia così di superare il suo valore. Questo spiega perché la produzione di bitcoin sia sempre più appannaggio di operatori specializzati che si stabiliscono in paesi dove l’energia e gli spazi in cui ammassare computer costano meno. Per i minatori, la convenienza dipende anche dal valore che la valuta digitale ha sul mercato. Nel momento di massimo splendore un singolo bit­coin è arrivato a essere scambiato per 20 mila dollari. Oggi si aggira intorno ai 9000 dollari. Perché questi violenti rialzi e ribassi? Non avere un’autorità che amministra e gestisce la moneta può avere il suo fascino. Per gli estimatori delle teorie monetarie più libertarie è addirittura la realizzazione di un sogno: una moneta regolata solo dal mercato e al riparo da qualsiasi ingerenza politica. Ma ci sono anche svantaggi, tra cui la mancanza di un soggetto in grado di stabilizzarne il valore, intervenendo per limitarne le oscillazioni. Per «qualcosa che vorrebbe fare la moneta», alti e bassi eccessivi costituiscono un grosso problema. Chi sarebbe mai disposto ad accettare come pagamento qualcosa che dopo una settimana vale la metà? O, viceversa, chi spenderebbe oggi una moneta che domani potrebbe valere il doppio? L’incapacità di mantenere un valore ha trasformato le valute digitali in strumenti per lo più speculativi. Vale a dire che si comprano bitcoin sperando che il loro valore salga, non per usarli al posto di dollari o euro. Il fatto che, anche per questa ragione, nessuna moneta digitale sia ancora riuscita a insidiare seriamente il denaro tradizionale, è il motivo per cui le autorità di controllo hanno sinora chiuso un occhio sul tentativo di sviluppare queste forme di pagamento alternativo. Alla ricerca della stabilità perduta Non è un caso che, tra le tante monete digitali che sono apparse in questi anni (sono ormai più di 1500!), le più recenti si basino su un sistema che cerca di assicurarne la stabilità. Così funziona, per esempio «Tether», che è costrui­ta per mantenere un legame tra il suo valore e quello del dollaro. Una prospettiva interessante per le monete digitali, il possibile ingresso in questo nuovo universo delle stelle di prima grandezza del web. Google, Amazon, Apple potrebbero decidere di dar vita a una loro moneta digitale per gestire gli scambi sulle loro piattaforme. Nel 2019 Facebook ha annunciato di essere al lavoro su una propria moneta virtuale denominata «Libra», moneta ancorata a un paniere di monete e quindi tendenzialmente stabile. La novità ha destato grande interesse, ma molti aspetti tecnici restano poco chiari e la repentina levata di scudi delle banche centrali ha sgonfiato il progetto. Libra sarebbe una sorta di soluzione ibrida. Una moneta sostenuta da una struttura simile a quella del bitcoin ma con un’autorità di riferimento privata con un qualche potere di gestione, che rimanda vagamente all’idea di banca centrale. Quadratura del cerchio oppure tradimento dell’idea alla base delle monete digitali? Passare da un denaro amministrato da autorità pubbliche a uno gestito da soggetti privati, non pare onestamente un grande passo in avanti. Il sogno anti sistema L’idea di moneta digitale prende forma negli ambienti culturali del cosiddetto «cyberpunk». Si tratta di una comunità nata nei primi anni Ottanta del secolo scorso e piuttosto articolata al suo interno. Il tratto distintivo di fondo è la convinzione che su Internet le tecnologie informatiche possano essere utilizzate per spezzare i tradizionali assetti economici e sociali per lo più in funzione di un maggior egualitarismo e di una più ampia libertà personale. L’idea di una moneta slegata da banche centrali e autorità di controllo ha quindi origini lontane ma si afferma durante la crisi finanziaria del 2008. Quando cioè la fiducia nel tradizionale sistema e nelle sue istituzioni vacilla. Il bitcoin è apparso come la risposta più credibile a queste istanze. È stato concepito come reazione a governi corrotti e istituzioni finanziarie inaffidabili. Non è un caso che il suo valore inizi a salire mentre prende piede il movimento «occupy Wall Street». È insomma una sorta di «surrogato» della fiducia che sta alla base dei sistemi di pagamento, una nuova fiducia creata artificialmente. E come ammettono i suoi stessi sostenitori i bit­coin hanno un valore finché chi li Usa pensa che lo abbiano (non che per l’oro o le monete tradizionali sia molto diverso… valgono perché la gente ritiene che valgono). Un’origine avvolta nel mistero Il dominio «bitcoin» viene registrato il 18 agosto 2008 da Satoshi Nakamoto. Si tratta di uno pseudonimo e nessuno ha ancora davvero capito chi si celi dietro di esso, se si tratti di una sola persona oppure di un gruppo. Tante le ipotesi circolate. L’indiziato numero uno è stato a lungo Satoshi Nakamoto, professore di informatica americano di origini giapponesi che ha sempre negato la paternità della nuova moneta. Nel 2015 un imprenditore australiano di nome Steven Wright ha affermato di essere il vero Nakamoto. Una rivelazione che ha trovato qualche riscontro in vecchie e-mail visionate da alcune riviste del settore, ma che non ha mai ottenuto conferme definitive. Si sono fatti i nomi anche di Nick Szabo e Hal Finney, il primo esperto di crittografia, il secondo uno sviluppatore morto nel 2014. Non mancano tesi più ardite che spaziano da un ruolo dei servizi segreti russi, cinesi, americani fino al fondatore di Tesla Elon Musk. 10 anni sulle montagne russe Dal suo debutto sul mercato, a inizio 2009, fino al 2013, il bitcoin fa poco notizia e oscilla tra 1 e 15 dollari. Il valore di tutti i bitcoin in circolazione non supera i 500 milioni di dollari. Per chi ha investito fin dall’inizio, si tratta già di guadagni di tutto riguardo. Mille dollari sarebbero diventati in 4 anni 15 mila, con un guadagno del 1400%. Ma il meglio (molto meglio) deve ancora venire. La situazione inizia a scaldarsi nel 2013, alla fine di quell’anno un bitcoin viene scambiato per oltre 1000 dollari. Segue una fase di declino, che durerà fino agli ultimi mesi del 2015, con quotazioni scese fino a 200 dollari. Nel 2016 si assiste a una decisa ripresa che riporta la moneta digitale in zona 800 dollari. Nel 2017 la mania bitcoin letteralmente esplode. Il suo valore vola dai 900 dollari di inizio anno ai 20 mila dollari del 17 dicembre. Siamo in una classica situazione di «bolla», dove tutti comprano per la convinzione che quanto acquistato oggi domani varrà di più. C’è davvero chi in poco tempo è diventato milionario. Sulla giostra bitcoin iniziano a salire anche pesi massimi della finanza come Jp Morgan o Goldman Sachs. Banche con una potenza di fuoco capace di condizionare le quotazioni di un mercato che, nonostante tutto, ha ancora dimensioni modeste. Nei mesi di massimo splendore il mercato del bitcoin è arrivato a valere complessivamente 300 miliardi di dollari. A titolo di paragone sul «Forex», ossia il mercato delle valute tradizionali, avvengono scambi per circa 4 mila miliardi di dollari al giorno. Quando i grossi investitori decidono di passare all’incasso, il bitcoin precipita a 3750 dollari. Meno 80% in 12 mesi. Dopo di che una nuova risalita, costellata di alti e bassi, fino a 9000 dollari. Capitolo 3 3,6,3 ovvero cosa fa una banca con i nostri soldi Pagare il 3% di interessi sui depositi della clientela, prestare questi stessi soldi chiedendo il 6% e alle 3 del pomeriggio andare a giocare a golf. Tre-sei-tre, una formuletta con cui veniva scherzosamente raccontata la confortevole vita di chi lavorava in banca. Banking is boring, l’attività bancaria è noiosa. Oggi molte cose sono cambiate, i modi con cui le banche fanno profitti si sono moltiplicati, sono più complessi. Sofisticati modelli matematici cercano di imbrigliare e gestire il rischio macinando profitti, i guadagni sono aumentati e la competizione si è fatta feroce. Tuttavia la formula 3,6,3 descrive ancora abbastanza bene quello che resta il cuore dell’attività bancaria. Ancora oggi mediamente il 60% circa dei ricavi di una banca deriva dalla differenza tra tassi applicati ai prestiti e ai depositi. Diciamo che aggiornata alle condizioni odierne la nostra formula potrebbe essere 0,2,6. Offro interessi zero, chiedo il 2% e me ne vado alle 18. Il «trucco» che fa funzionare le banche Per capire meglio questo meccanismo, diamo prima una veloce occhiata a come è strutturato il bilancio di una banca. Imprese e famiglie depositano i loro soldi nei conti correnti. I risparmi delle famiglie sono una forma di finanziamento molto ambita. Costano poco come interessi e, nel loro insieme, sono molto stabili. Stati e banche se li contendono. I primi offrendo titoli di Stato, le seconde conti correnti e servizi. Per la banca questi depositi rappresentano un «passivo». Ossia una voce del bilancio che «drena» risorse. Il fatto che i soldi di cui una banca diventa custode rappresentino un costo è forse un poco contro-intuitivo. Ma la banca deve pagare degli interessi (per quanto attualmente molto bassi) ai depositanti e questi soldi non sono e non saranno mai una sua proprietà. In altri termini, il deposito sul conto corrente è una specie di prestito che il cliente fa alla banca ottenendo in cambio interessi, comodità e sicurezza. Un prestito che non ha scadenza e di cui si può chiedere la restituzione, parziale o totale, in qualsiasi momento. Ma perché allora la banca cerca questi soldi? Benché non siano suoi, la banca può utilizzare i depositi per erogare prestiti a famiglie o imprese che vogliono, per esempio, comprare una casa o costruire un nuovo stabilimento. Questi finanziamenti si chiamano «impieghi» e nel bilancio costituiscono un «attivo». Da questi prestiti la banca ottiene infatti un guadagno, sotto forma di interessi pagati dai debitori. Interessi che sono più alti rispetto a quelli che la banca paga ai suoi depositanti. Sono più alti perché la durata di un prestito è solitamente lunga (si pensi a un mutuo ventennale) e i rischi per chi presta sono maggiori. A questo punto una domanda sorge spontanea: ma se la banca presta a qualcun altro i soldi dei depositi come è possibile che i correntisti possano ritirarli in qualsiasi momento? Qui c’è il piccolo grande «trucco» che fa funzionare ogni sistema bancario: una banca non ha mai a disposizione tutti i soldi che sono stati depositati dai suoi clienti. Però ne ha sempre almeno un po’. In situazioni normali, non accade mai che tutti i depositanti si rechino contemporaneamente a ritirare i loro soldi (anzi, solitamente c’è chi ritira ma c’è anche chi deposita), e la disponibilità di cassa della banca è sufficiente a soddisfare le esigenze quotidiane della clientela. Solo in situazioni particolari, questo equilibrio si infrange. Ciò succede, per esempio, quando si verifica una corsa agli sportelli, l’incubo di qualsiasi banchiere su cui torneremo più avanti. Chi deposita i soldi su un conto corrente non solo vuole poterli ritirare in qualsiasi momento, vuole anche essere sicuro di riaverli tutti. Quindi l’attività della banca non deve in nessun caso intaccare il valore dei depositi. Le perdite che una banca subisce a causa di investimenti sbagliati, prestiti non rimborsati ecc., non intaccano minimamente i depositi ma colpiscono il «capitale». Si tratta dei soldi che i soci (ossia i padroni della banca) investono nell’istituto, soldi che fruttano se le cose vanno bene e si assottigliano in caso contrario. Più il capitale è elevato in rapporto all’ammontare complessivo dei prestiti, maggiore è la capacità della banca di far fronte ai periodi di difficoltà. Insomma la banca è più solida. Quando si esagera Uno dei problemi alla base della grave crisi del 2008 è stata proprio l’insufficienza del capitale di molte banche. In alcuni casi il rapporto tra capitale e prestiti (in gergo tecnico «leva») arrivava a 1 su 40. Ossia per ogni mille euro di capitale, una banca aveva investimenti per 40 mila euro. In queste condizioni, una perdita di poco più del 2% sull’insieme degli investimenti comporta il completo azzeramento del capitale. Una situazione estremamente rischiosa. Dopo la crisi, lo sforzo principale delle autorità di vigilanza è stato così quello di obbligare le banche ad aumentare il livello del loro capitale. C’è un motivo per cui le banche sono restie a incrementare la loro solidità: più è basso il capitale richiesto, più alti sono i guadagni che può fruttare. Ipotizziamo che il capitale minimo richiesto sia pari al 10% degli impieghi. Ossia con 1000 euro di capitale posso disporre di 10 mila euro da prestare o investire. Se il loro utilizzo frutta un guadagno del 2%, ossia 200 euro, il capitale di 1000 euro ha generato un profitto del 20%. Se la soglia minima richiesta viene raddoppiata, il capitale versato dai soci dovrebbe salire a 2000 euro a fronte dello stesso ammontare di prestiti e investimenti. Quindi, il medesimo guadagno di 200 euro, significherebbe un profitto del 10%. Non fu solo l’insufficienza di capitale a favorire la crisi del 2008. Contribuì anche una rivoluzione nella gestione dei rischi, ottenuta grazie allo sviluppo di innovazioni finanziarie. La deregolamentazione dei servizi finanziari avviata negli anni Ottanta aumentò la concorrenza tra banche. Con benefici per i clienti ma generando anche una pressione crescente sugli istituti per adottare soluzioni finanziarie innovative e assumere più rischi. Senza addentrarci troppo in tecnicalità, a volte davvero molto complesse per gli stessi addetti ai lavori, concentriamoci sul concetto di fondo. In passato, quando una banca erogava un mutuo o un prestito, questo rimaneva sul suo bilancio fino alla scadenza. Era quindi interesse della banca assicurarsi che questo prestito venisse concesso a un soggetto in grado di far fronte all’impegno delle rate, che fornisse adeguate garanzie. Oggi le cose funzionano diversamente. La banca eroga i mutui, dopodiché questi mutui vengono «impacchettati» e venduti a qualcun altro. Come? La stessa banca crea una nuova società dal nulla che, in concreto, è poco più di un domicilio in qualche paese dove si pagano poche tasse. Una specie di «scatola». Questa società (in gergo Spv, special purpose vehicle) acquista i mutui della banca. Con quali soldi? Con quelli che recupera vendendo obbligazioni sul mercato. Interessi e rimborsi finali di queste obbligazioni verranno pagati con i versamenti delle rate dei mutui che fanno parte del «pacchetto» venduto dalla banca. In questo modo il rischio di un’eventuale insolvenza dei debitori non è più a carico della banca ma viene sminuzzato e diviso tra chi compra le obbligazioni emesse dalla società veicolo. A ogni passaggio, un intermediario guadagna qualcosa in forma di commissioni. Ma, soprattutto, la banca toglie i mutui dal suo bilancio e può erogarne di nuovi, senza la necessità di rafforzare il suo capitale. Ripetendo l’operazione ancora, ancora e ancora. È la «magia» delle famigerate cartolarizzazioni che hanno però un grave e pericoloso effetto collaterale. Se la banca concede un mutuo e poi se ne libera, le interessa ben poco essere sicura che chi lo ottiene sia un debitore affidabile. Né questa valutazione la può fare chi ha comprato le obbligazioni costruite su questi mutui, magari un fondo pensione, che non ha nessun tipo di rapporto con i mutuatari coinvolti. In teoria, a tutelarci dai rischi eccessivi, dovrebbero pensarci le agenzie di rating, che come lavoro fanno proprio quello di valutare quanto sia sicuro per chi lo compra un titolo obbligazionario. Ma con prodotti finanziari complessi e con un accesso parziale alle informazioni necessarie, è molto difficile effettuare valutazioni accurate. In questa catena dove, in teoria, tutti hanno qualcosa da guadagnare, sparisce un soggetto in grado di controllare fino a che punto il livello di rischio si sta alzando. L’illusione ipnotica fu quella di supporre che, raggruppando tanti mutui diversi, il rischio complessivo si riducesse. Poiché, si diceva, è quasi impossibile che il tasso di insolvenza salga contemporaneamente in tutte le aree geografiche. Rincorrere le stelle e cadere nella polvere Alla festa partecipano tutti, non solo banche statunitensi ma anche quelle europee attraverso le loro controllate Usa. Nel 2008 si concedevano mutui con tale noncuranza che il sistema non poteva far altro che crollare rovinosamente. Particolarmente emblematici i mutui Ninja (no income no job, no asset: senza lavoro, senza reddito, senza ricchezze) erogati a persone non in grado di ripagarli né di offrire una anche minima garanzia. Ma erano strutturati in modo che gli interessi sulle prime rate fossero irrisori, salvo poi crescere significativamente negli anni. Prima dello scoppio della crisi, il 23% dei mutui immobiliari americani era «subprime», ossia di basso livello. Di questi quasi l’80% era stato cartolarizzato, spezzettato e sparso per tutto il sistema finanziario. Le autorità non erano particolarmente vigili, anche per input di natura politica. Permettere alle famiglie, anche le meno abbienti, di accedere al credito era, e rimane, un modo per mettere una pezza al ristagno salariale e alle sofferenze della classe media. La ricetta per il disastro. La miccia della bomba mutui si accese nel 2007 quando il tasso variabile più utilizzato salì dal 7 al 10,5% provocando una prima ondata di insolvenze. Quando il castello di carte è collassato, nessuno sapeva più esattamente che cosa aveva comprato e, non sapendolo, nessuno si fidava più di nessuno. Come abbiamo visto, se manca la fiducia qualsiasi sistema, economico e/o finanziario, collassa. Il disastro è stato evitato solo grazie all’intervento degli unici soggetti in grado di immettere fiducia nel sistema, sotto forma di fiumi di denaro: le banche centrali. Si sono fatte carico di acquistare miliardi e miliardi di titoli che nessuno altrimenti avrebbe comprato, ripristinando a forza il flusso di denaro che muove il sistema del credito, la circolazione sanguigna dell’economia. Più di dieci anni dopo non ne siamo ancora del tutto fuori. Le grandi banche centrali tengono ancora a bilancio titoli per trilioni di dollari o euro acquistati nelle fasi più cruente della crisi. Le condizioni monetarie rimangono incredibilmente espansive, con tutti i possibili effetti collaterali ancora in opera (nascita di nuove bolle, aumento delle diseguaglianze, aumento dei rischi di portafoglio ecc.). Una condizione nuova, senza precedenti, di cui rimane incerto l’effetto sul lungo periodo. La corsa agli sportelli La corsa agli sportelli è l’incubo di qualsiasi banca. Si verifica quando, nello stesso momento, tutti i depositanti vogliono indietro i loro soldi e si presentano agli sportelli per reclamarli. Un comportamento che può scatenarsi quando iniziano a circolare dubbi sulla solidità di una banca e sulla sua capacità di restituire i soldi. Poiché, come abbiamo visto, una banca non tiene mai in cassaforte e in forma liquida tutti i depositi, ripagarli interamente in breve tempo è tecnicamente impossibile. Questo non significa tuttavia necessariamente che una banca sia insolvente. Potrebbe semplicemente avere bisogno di tempo per vendere i suoi asset o richiedere il rientro di alcuni finanziamenti concessi. Potrebbe essere semplicemente «illiquida», priva di soldi contanti. Ma quando si scatena il panico, tutti vogliono riavere i loro soldi il prima possibile e, come recita un detto della finanza, liquidity kills fast, la (carenza di) liquidità uccide in fretta. In passato la corsa agli sportelli non era eventualità così remota. Per scongiurare questa calamità sono stati via via messi in campo diversi accorgimenti. Alle banche centrali è stata data la possibilità di intervenire a sostegno di un istituto in difficoltà, sono stati fissati requisiti di capitale più stringenti e sono state create garanzie sui depositi. Nell’area euro tutti i depositi sono garantiti fino a un ammontare di 100 mila euro. Quindi, se anche una banca dovesse fallire, la gran parte dei correntisti non avrebbe nulla da temere. Ciò non toglie che anche di recente si sia assistito a un caso di corsa agli sportelli, proprio qui in Europa. È accaduto in Inghilterra nel 2008, quando i clienti di «Northern Rock» si recarono in massa presso le filiali della banca, primo caso di questo tipo da 150 anni. Northern Rock in sostanza si affidava massicciamente al mercato interbancario (prestiti tra banche) per finanziare l’erogazione di mutui ai suoi clienti. Appena il mercato dei capitali si paralizzò per la mancanza di fiducia, la banca collassò, costringendo il Governo britannico a nazionalizzare, non senza polemiche, l’istituto. Chi paga il conto? Salvare una banca è costoso. Lasciarla fallire, spesso lo è di più per le conseguenze che può provocare sul sistema finanziario e sull’economia. Ogni volta che si presenta una seria crisi bancaria, Stati e Governi si trovano così di fronte a un’alternativa molto spiacevole. Per di più, la regola non scritta per cui le grosse banche devono essere, in ogni caso, salvate favorisce da parte di chi le guida comportamenti più rischiosi nella ricerca di profitti. Un fenomeno noto come «azzardo morale» o moral hazard. Per queste ragioni l’Europa ha scelto di adottare un sistema in parte diverso. Si tratta del cosiddetto bail-in, ossia salvataggio dall’interno. Il principio è che quando una banca deve rafforzare il capitale per non fallire, a farsene carico non sono più solo gli azionisti ma anche obbligazionisti e, in una certa parte, persino i suoi correntisti. Per questi ultimi però solo nella parte dei loro depositi che supera i 100 mila euro e per la parte che eccede questa soglia. Lo Stato interviene, eventualmente, solo in un secondo momento. Questa soluzione dovrebbe indurre chiunque abbia a che fare con una banca a valutarne con più attenzione la solidità e dovrebbe rendere meno salato il conto per l’insieme dei contribuenti di un eventuale salvataggio. Shadow banking,i misteri della finanza ombra Il nome è probabilmente più sinistro di quanto non rappresenti in realtà. Sistema bancario ombra restituisce l’idea di traffici opachi. Non è così o lo è solo in minima parte. Con una definizione riduttiva ma efficace, lo shadow banking include tutti quei soggetti che operano sul mercato del credito e dei capitali senza essere sottoposti ai vincoli delle banche tradizionali e alla medesima vigilanza da parte di banche centrali. Aziende che prestano per breve periodo la liquidità temporaneamente in eccesso, fondi monetari ecc. Possono operare con meno vincoli poiché non raccolgono risparmi direttamente dal pubblico. Meno vincoli ma anche meno reti di sicurezza. A differenza delle banche tradizionali, non esiste nessuna garanzia pubblica implicita o esplicita per questo tipo di attività. Oggi è nel mondo dello shadow banking che si muove la gran parte dei flussi di denaro e dei finanziamenti. È una specie di mercato all’ingrosso dei capitali, incentrato sul dollaro. Come emerso durante la crisi del 2008, non esiste una effettiva separazione tra mondo che opera alla luce del sole e mondo che opera nell’ombra. Gruppi bancari molto grossi hanno divisioni che operano in questo universo parallelo. In tal caso spesso sono loro a fornire una sorta di assicurazione privata, garantendo che qualora la «divisione ombra» dovesse incontrare problemi di liquidità interverrebbero per tamponare il problema. Così la distanza di sicurezza che separa lo shadow banking dai normali depositi si accorcia pericolosamente e i problemi del mondo sommerso finiscono per lambire da vicino anche governi e banche centrali. Capitolo 4 Angeli diventati demoni, l’oscura parabola dei derivati I derivati, prodotti finanziari dalla natura luciferina, sono associati all’idea di una speculazione feroce e vorace. Strumenti capaci di mettere in ginocchio aziende o interi paesi, a vantaggio di un manipolo di grandi finanzieri. Utilizzati per «spennare» risparmiatori, inconsapevoli del rischio. C’è, senza dubbio, del vero. Ma non tutto il vero. I derivati nascono, e sono tutt’ora utilizzati, come prodotti che consentono di maneggiare, spostare e suddividere il rischio. A fin di bene insomma. Aumentano la sicurezza di un investimento rendendolo meno pericoloso. La riduzione dell’incertezza è sempre molto gradita a chi compra o vende. Tralasciando i tempi antichi, da cui pure sono giunte notizie di contratti simili (a cominciare dal codice di Hammurabi del 1750 a.C.), i primi derivati moderni furono «futures» su prodotti agricoli. Per un coltivatore è impossibile prevedere se la stagione in arrivo sarà favorevole o meno, secca o con troppa pioggia. Se i raccolti saranno abbondanti oppure scarsi e quindi a che prezzo potrà vendere i suoi prodotti. La stessa incertezza, ma di verso contrario, grava sui grossisti che comprano. Se i prezzi saranno alti sarà un bene per l’agricoltore, in caso contrario i benefici andranno all’acquirente. Entrambe le parti potrebbero però scegliere di rinunciare a parte dei possibili guadagni per contenere eventuali perdite. Prima di conoscere come andrà la stagione possono accordarsi per fissare in anticipo il prezzo della compravendita. Ecco che nasce un contratto «future». Verosimilmente si tratterà di un prezzo a metà tra i due estremi possibili. Il rischio viene così suddiviso tra i due partecipanti: comunque vada, nessuno dei due farà guadagni strepitosi ma non dovrà neppure sopportare perdite esagerate. È un mondo difficile… L’incertezza alberga in ogni angolo del mondo e gli investitori non la amano. Come il loro nome lascia intendere, tutti i derivati hanno in comune la caratteristica di «derivare» il loro valore da un prodotto sottostante. Contratti futures, sono stati creati su qualsiasi genere di materia prima e poi su valute, azioni, obbligazioni, titoli di Stato ecc. Ora cerchiamo di capire perché questi scudi contro il rischio possono avere anche una natura «malvagia». Grazie alle facoltà che attribuisce al suo possessore, un derivato ha anche un valore in sé e può essere venduto o comprato. Spesso questo accade fuori da mercati regolamentati (in questo caso si parla di scambi Otc, over the counter) e, in questo caso, non ci sono limiti al modo in cui un contratto può essere strutturato. Ipotizziamo si tratti di un contratto future che mi dà il diritto di acquistare il petrolio a 50 dollari. Il valore di questo derivato aumenta man mano che il prezzo del petrolio sale sopra i 50 dollari. Ciò accade a prescindere dal fatto che il suo possessore decida di comprare davvero dei barili di greggio. Anzi, nella grande maggioranza dei casi il rea­le trasferimento del «sottostante» non avviene. Meno del 2% dei contratti futures si concludono con l’effettivo passaggio dei beni a cui sono collegati. Solo per quanto riguarda il petrolio, ogni giorno vengono realmente scambiati nel mondo circa 80 milioni di barili, mentre nel mercato dei derivati i barili che si spostano, ma solo virtualmente, sono oltre un miliardo. In questo tipo di utilizzo il derivato non serve più per ridurre i rischi ma serve per fare esattamente l’opposto: esporsi al rischio scommettendo su variazioni di prezzo favorevoli. I derivati hanno un’altra caratteristica «esplosiva»: grazie al cosiddetto effetto leva riescono a moltiplicare profitti (e perdite). Vediamo, per esempio, come si possa guadagnare sul petrolio… senza vederne neppure una goccia. Potrò comprare, poniamo per 100 dollari, un derivato che mi dà la facoltà di acquistare 100 barili al prezzo di 50 dollari l’uno. Ipotizziamo che alla scadenza del contratto il prezzo del greggio sia salito a 60 dollari. A questo punto potrei comprare 100 barili a 50 dollari spendendo 5000 dollari e poi rivenderli a 60 dollari, incassandone 6000 e guadagnandone 1000. L’investimento iniziale era appena 100, un profitto del 900%! Ma anche senza spostare davvero 100 barili di greggio, posso, più comodamente, chiudere il contratto con la mia controparte e incassare i 1000 dollari. Ipotizziamo invece che il prezzo del petrolio scenda anche solo a 49,99 dollari. A quel punto il derivato che mi dà la possibilità di comprarlo a 50 dollari non vale nulla, è carta straccia. Avrò quindi perso tutti i 100 dollari investiti. Questo rende l’idea di quanto i derivati possano essere al contempo e allettanti e pericolosi. Del resto, è regola base che le possibilità di ingenti guadagni comportino sempre alti rischi. Una specie di «chi non risica non rosica» al cubo. Corsa senza freni A partire dal 1970, grazie anche alla diffusione dei computer, negli Stati Uniti si è assistito a una proliferazione di strumenti derivati, sempre più complessi e studiati per qualsiasi esigenza. Questo tumultuoso sviluppo ha portato alla nascita di prodotti di tale complessità che solo poche persone al mondo sono in grado di comprenderne il funzionamento e di attribuirgli un prezzo corretto. Tra questi nuovi derivati ce ne sono almeno due che hanno avuto un ruolo chiave sia nella crisi finanziaria del 2008 sia in quella dei debiti sovrani europei del 2012: i Cdo (collateralized debt obbligation) e i Cds (credit default swap). Come abbiamo già visto nel capitolo precedente, una pratica molto diffusa negli anni 2000 era quella della cartolarizzazione dei mutui immobiliari. I mutui venivano raggruppati e venduti a una società creata dal nulla. Questa società si finanziava emettendo obbligazioni. Più esattamente tre tipi di obbligazioni: senior, più sicure poiché con precedenza nei rimborsi, mezzanine e junior, più rischiose e conseguentemente con interessi più alti. Il gioco non finiva qui, anche perché a ogni passaggio fioccavano guadagni in commissioni. Queste obbligazioni venivano quindi a loro volta re-impacchettate, acquistate da una società che si finanziava emettendo altre tranches di obbligazioni, in questo caso spesso con più di tre livelli, dando vita appunto alle collateralized debt obbligation, obbligazioni garantite da titoli di debito. Una sorta di obbligazioni al quadrato insomma. Esistono, esistevano anche «Cdo sintetiche», ossia Cdo costruite impacchettando non obbligazioni ma quei Cds di cui parleremo. Confusi? È normale. Quando scoppiò la crisi 2008 neppure la grandissima parte degli addetti ai lavori capiva più nulla. Nessuno era più capace di stabilire dove fossero finite queste obbligazioni, cosa ci fosse dentro e, soprattutto, quanto valessero. Questo continuo impacchettare, dividere, rivendere e poi da capo, ebbe come effetto di mimetizzare a tal punto il rischio da renderlo irriconoscibile e irrintracciabile. Persino le agenzie di rating, che questo fanno di lavoro, si trovarono nell’incapacità di valutare correttamente l’affidabilità di questi prodotti finanziari sbagliando, in alcuni casi clamorosamente, i loro giudizi di affidabilità. Prodotti giudicati erroneamente più sicuri di quello che erano, finirono così nei bilanci di banche, fondi pensione, assicurazioni di mezzo mondo. Si comprava a scatola chiusa, fidandosi di cosa c’era scritto sulla scatola, ma senza mai aprirla perché nessuno aveva più la chiave del lucchetto. Assicurazioni letali I Cds offrivano, in teoria, un modo per proteggersi da tutti questi rischi mimetizzati. Si tratta di una specie di assicurazione sulla vita… di qualcun altro. Acquistando un Credit Default Swap posso assicurarmi contro la possibilità che il soggetto che ha emesso un’obbligazione fallisca e quindi non sia in grado di pagare. Come per qualsiasi polizza dovrò pagare un premio periodico a chi offre questa garanzia e si impegna a restituire tutto il valore nominale dell’obbligazione in caso di default. La cosa particolare è che questa protezione posso acquistarla anche senza possedere l’obbligazione assicurata. Semplicemente perché penso e spero che il valore della polizza aumenterà poiché l’obbligazione sta diventando più rischiosa. I Cds nascono nei primi anni Novanta, ideati da esperti della banca d’affari statunitense JP Morgan. «Esplodono» però negli anni immediatamente antecedenti alla grande crisi finanziaria. Nel 2007 il valore dei possibili rimborsi da Cds raggiunge il picco di 61 mila e 200 miliardi di dollari, circa 40 volte il Prodotto interno lordo italiano. Particolarmente attivo nell’emissione e commercializzazione di Cds fu il colosso statunitense Aig (american insurance group). In particolare vendeva Cds su prodotti finanziari collegati ai mutui subprime. Così facendo finì però per essere a sua volta esposto al rischio di fallimenti oltre ogni limite ragionevole. Scoppiata la crisi, man mano che gli emittenti fallivano e i possessori di Cds rivendicavano i loro rimborsi, Aig si trovò quindi nell’impossibilità di pagare tutti i rimborsi che avrebbe dovuto garantire. Il gruppo assicurativo finì quindi a sua volta in bancarotta e, anche in questo caso, dovette intervenire il Governo orchestrando un salvataggio da diverse centinaia di miliardi di dollari. Contagio attraverso l’Atlantico Tra il 2010 e il 2012 gli effetti della crisi si spostano in Europa. Ma questa volta a rischio non erano banche, assicurazioni o fondi di investimento. Nell’occhio del ciclone erano finiti gli Stati dell’Europa mediterranea: Grecia, Spagna, Portogallo e Italia. Sono tutti paesi che hanno finanze pubbliche più fragili rispetto a quelle degli Stati dell’Europa continentale. Hanno debiti, e quindi titoli di Stato in circolazione, alti, se rapportati alle dimensioni delle loro economie. Sono quindi più esposti alle crisi finanziarie e agli attacchi della speculazione. Per ironia della sorte le stesse banche salvate con i soldi pubblici, iniziano a fare puntate sul fallimento di uno di questi paesi. Come? Con molte tecniche tra cui l’acquisto di Cds sui loro titoli di Stato dei paesi meno solidi. Come abbiamo già visto, più un paese viene percepito come rischioso più gli interessi che deve pagare su titoli e debito aumentano. Ma se questa spesa cresce i conti pubblici soffrono ancora di più e quindi il rischio aumenta ulteriormente. E così si innesca un circolo vizioso che si può avvitare molto in fretta. Man mano che il pericolo connesso, per esempio, a un Btp sale, cresce anche il valore di un’assicurazione che mi garantisce il rimborso del titolo in caso di fallimento, i Cds appunto. Purtroppo i Cds, a loro volta, trasmettono un segnale ai mercati. Più costa assicurarsi, più significa che il rischio è alto. E quindi, da capo, chi investe pretende interessi più alti. Questo «giochino» ha portato pericolosamente vicino alla bancarotta, non solo la Grecia, di fatto tecnicamente fallita, ma anche l’Italia. Un disastro scongiurato solo grazie all’intervento della Banca centrale europea a difesa di questi paesi, mossa imprescindibile per la tenuta dell’intera area euro. In seguito le vendite di Cds «naked», ossia nudi, perché posseduti senza detenere i titoli che sono assicurati, sono state vietate. Sono stati introdotti controlli, garanzie e normative più stringenti per chi opera con questi strumenti. Ma i mercati trovano sempre un modo per arginare i vincoli. Qui volere è davvero potere. A bloccare realmente la speculazione non sono state le regole ma gli interventi dei governi e soprattutto della Bce. Una regola non scritta che qualsiasi operatore dei mercati conosce bene è «mai scommettere contro la banca centrale». Soprattutto se si tratta di banche centrali potenti come Fed e Bce che dispongono di munizioni illimitate o quasi. I sostenitori più accesi del mercato non mancano di rimarcare come anche la speculazione più spregiudicata abbia una sua funzione: ripulire il sistema dalle inefficienze. Sono i predatori che eliminano gli animali più deboli aumentando la salute complessiva del gregge che attaccano. In fondo, si fa notare, la speculazione non attacca mai aziende o paesi solidi ed efficienti. Per scatenarsi gli speculatori sfruttano una debolezza reale, amplificandola e approfittandone ai fini del profitto, anche a costo di «uccidere» la loro vittima. È un ragionamento freddamente logico e asettico, che può avere un senso se applicato a qualcosa come una lotta tra batteri o coccodrilli. Lo ha molto meno se si considerano i mercati per quello che sono realmente. Non un’entità astratta dotata di vita autonoma che la società deve subire ma una creazione dell’uomo che, in ultima analisi, dovrebbe funzionare al suo servizio. Far fallire un paese significa certo una condanna per sbagli nella gestione della finanza pubblica che molto probabilmente ci sono stati, forse anche un insegnamento per il futuro. Ma significa anche milioni di disoccupati, povertà, esistenze distrutte, sofferenza. Ed esistono metodi meno traumatici per traghettare un paese fuori dalle sue difficoltà. L’esigenza del profitto non esclude che si possano mitigare gli effetti più dolorosi della speculazione più brutale, a beneficio della società nel suo complesso. Italia sull’orlo del baratro Tra il 2011 e il 2012 l’area euro ha rischiato seriamente di finire in frantumi. Si era rotto un incantesimo e i mercati se ne erano improvvisamente accorti. Quando l’unione monetaria prese forma, uno degli effetti più evidente fu l’allineamento verso il basso dei tassi di interesse sui titoli di Stato dei paesi che ne facevano parte. Una volta entrati nel club della moneta unica, anche paesi in precedenza più rischiosi come Italia, Grecia, Spagna o Portogallo venivano considerati sicuri. In una comunità in fondo ci si aiuta tra membri, o almeno si dovrebbe farlo. Questo è quanto pensavano i mercati. Ma nel 2009, con il sistema finanziario ancora tenuto in vita artificialmente dalle banche centrali, deflagra la crisi greca. Atene ammette di aver truccato i suoi conti: il deficit si colloca al 15% del Pil. Il peso economico della Grecia sull’insieme dell’area euro è molto ridotto (il Pil greco è la metà di quello della sola Lombardia) ma le banche europee, soprattutto francesi e tedesche, ad Atene hanno prestato miliardi. Un salvataggio pubblico della Grecia sarebbe di fatto un salvataggio delle banche. Difficile da far digerire all’opinione pubblica. Nel maggio 2010 i capi di Governo europei raggiungono un accordo informale e non reso pubblico per accollare alle banche parte dei costi del salvataggio di Atene. L’impegno per gli istituti di credito era quello di non vendere i titoli di Stato greci in loro possesso almeno fino al 2013, nonostante la perdita di valore. Poco tempo dopo si scopre che le banche francesi non hanno rispettato questo impegno. I tedeschi, comprensibilmente si infuriano, la coesione, già precaria, tra i paesi dell’eurozona vacilla. In ottobre nell’incontro bilaterale di Deauville in Francia, Parigi e Berlino decidono così di mettere nero su bianco e ufficializzare il principio del coinvolgimento del settore privato (ossia le banche e altre istituzioni finanziarie). Per i mercati è una doccia ghiacciata. Significa che un titolo spagnolo o portoghese è molto più pericoloso di uno tedesco-olandese, perché non esiste un’entità europea che davvero preveda una condivisione di rischi e problemi. Così gli spread tornano ad allargarsi e i rendimenti di Portogallo, Spagna, Italia volano. Gli interessi dei titoli decennali italiani toccano il 7% con un differenziale (spread) rispetto all’equivalente titolo tedesco del 5,75%. Il 7% è considerato un livello oltre il quale la sovranità di un paese vacilla, poiché per finanziarsi interessi così alti è troppo costoso e bisogna quindi chiedere aiuto a soggetti esterni come il Fondo monetario internazionale. Che presta i soldi ma in cambio detta la linea di politica economica e impone riforme. La speculazione soffia sul fuoco della crisi, si vendono allo scoperto i titoli a rischio, si usano i Cds, il cui valore lievita man mano che i rischi aumentano. Soltanto la decisa presa di posizione della banca centrale europea con l’avvio di una serie di interventi e, nel 2012, con la promessa di Mario Draghi di fare «whatever it takes», qualsiasi cosa sia necessario, per salvaguardare l’area euro, porranno fine alla fase più cruenta della crisi europea. Alla bottega dei derivati, prodotti per tutti i gusti e tutte le tasche Future: contratti derivati che prevedono la possibilità di acquistare una determinata quantità di un prodotto, a un prezzo prefissato e a una data prestabilita. Una volta sottoscritti possono essere scambiati prima della loro scadenza. I futures sono trattati su mercati regolamentati, prevedono delle fattispecie standard quanto a scadenze, regole, e quantità. Man mano che la scadenza si avvicina il prezzo del contratto future si avvicina a quello che il prodotto trattato ha in quel momento sul mercato. Opzione Call: contratto che attribuisce la facoltà (non l’obbligo) di acquistare prodotti finanziari come azioni o obbligazioni a un prezzo prefissato. Esistono «call» dette di tipo americano che permettono di procedere all’acquisto in qualsiasi momento prima della loro scadenza. Le call «europee» possono invece essere esercitate solo alla scadenza. Chi acquista una «call» spera che il prezzo delle azioni aumenti. Opzione Put: il contrario della «call», offre la possibilità di vendere a un prezzo prefissato. Si guadagna se il prezzo delle azioni oggetto dell’opzione scende prima della scadenza. Come per le call possono essere di tipo «europeo» o «americano». Irs (interest rate swap): accordo tra due parti (esempio due società), solitamente messe in contatto da una banca, per scambiarsi un flusso di interessi a tasso fisso con uno a tasso variabile su un determinato ammontare di denaro. Un debitore che ha un finanziamento a tasso variabile potrebbe per esempio ripararsi dall’eventualità di un rialzo dei tassi sottoscrivendo un contratto Irs. Otc e collateralizzazione: in questo caso non si tratta di contratti derivati. Otc è la sigla di over the counter. Ossia all’esterno di mercati regolamentati. È qui che vengono scambiati la maggior parte dei derivati. Il fatto che non esistano vincoli fa sì che l’unico limite alle caratteristiche dei contratti sia la fantasia delle parti. Questo però fa anche sì che i rischi aumentino. Sui mercati regolamentati hanno però il vantaggio di avere controparti centrali che si fanno garanti dell’adempimento finale dei contratti, riducendo il rischio di inadempienza. Cdo (colletaralized debt obligation): sono derivati costruiti impacchettando obbligazioni garantite da crediti (mutui, prestiti). Per acquistare questi pacchetti una società si finanzia emettendo a sua volta obbligazioni sul mercato. Le Cdo sono un sistema per segmentare e suddividere ulteriormente i livelli di rischio. Cds (credit default swap): assicurazioni che permettono di liberarsi del rischio di credito (fallimento del debitore e mancato rimborso). Un assicuratore emette Cds su determinate obbligazioni. Chi li compra paga un premio periodico per ottenere il pieno rimborso del titolo in caso di fallimento dell’emittente. I Cds possono essere comprati anche senza possedere i titoli che assicurano. Strategia speculativa che punta sull’aumento del valore della «polizza» man mano che aumentano i pericoli di fallimento. Quando si gioca con il fuoco, anche i Nobel finiscono per bruciarsi Una vicenda emblematica per comprendere il potenziale distruttivo dell’uso spregiudicato di derivati, leva finanziaria e vendite allo scoperto, è quello del fondo statunitense Long-Term Capital Management. Creato nel 1994 il fondo aveva tra i suoi membri anche Myron Scholes e Robert Merton che tre anni più tardi avrebbero vinto il premio Nobel grazie alle loro teorie per determinare il valore dei derivati. La principale strategia del fondo era quella di una sofisticata tecnica di arbitraggio. Ossia venivano sfruttate piccole differenze di prezzo che possono temporaneamente crearsi tra prodotti finanziari, teoricamente identici. Facciamo l’esempio di due obbligazioni con uguale scadenza emesse dalla stessa società. Per qualche ragione può capitare che una delle due obbligazioni sia momentaneamente più «liquida», vale a dire che sia più facilmente vendibile sui mercati senza causare significative variazioni di prezzo. Poiché questa caratteristica costituisce un valore aggiunto per il suo possessore (meglio poter vendere all’istante in caso di bisogno piuttosto che dover aspettare un tempo più o meno lungo), l’obbligazione avrà temporaneamente un prezzo leggermente più alto. In un mondo come quello della finanza, dove tutto accade ormai alla velocità della luce, queste differenze tendono a correggersi molto rapidamente. Tuttavia per chi è altrettanto rapido e può muovere grosse somme di denaro, possono generare grossi guadagni. Nei primi anni di attività il fondo riuscì a offrire ritorni ai suoi sottoscrittori del 21% annuo. Il fondo Ltcm cercava, scovava e sfruttava momentanee differenze di prezzo tra prodotti identici e la tendenza a riallinearsi dei valori nel tempo. Comprava i titoli sottovalutati e, contemporaneamente, vendeva allo scoperto (ossia senza possederli davvero) i titoli sovraprezzati. I derivati offrono questa possibilità di vendite differite nel tempo. Così se prima della scadenza il prezzo diminuisce (come probabile secondo i calcoli Ltcm) posso guadagnare sulla differenza tra il prezzo stabilito in anticipo e quello che mi verrà pagato. La leva era molto spinta. Il fondo prendeva cioè a prestito molti soldi rispetto a quelli di cui disponeva, fornendo in garanzia ai creditori i titoli sui quali investiva con quelli stessi soldi. Nel 1998 la Russia dichiara default sul suo debito. Questi eventi non hanno conseguenze solo per il paese direttamente coinvolto ma contagiano tutti quelli con caratteristiche simili. Inoltre, poiché i mercati si spaventano, innescano una corsa a vendere i prodotti più rischiosi a favore di quelli più sicuri. La liquidità è uno degli aspetti che determinano la sicurezza di un titolo. Più è alta, più la sicurezza cresce. Si verificò quindi un aumento abnorme del differenziale di rendimento tra titoli uguali ma con diversa liquidità, quelli su cui era impostata la strategia di Ltcm. I finanziatori del fondo iniziarono a quel punto le loro «chiamate di margine» (margin call). Ossia, ritenendo che il valore dei titoli conferiti a garanzia del prestito si fosse ridotto troppo chiedevano indietro i loro soldi. Avendo un capitale molto esiguo rispetto ai finanziamenti ottenuti, il fondo si trovò nell’impossibilità di adempiere a queste richieste e fu quindi costretto a dichiarare bancarotta. Gli ingredienti sono gli stessi che, 14 anni più tardi e su scala molto più grande, portarono al crack Lehman Brothers. Capitolo 5 Il mondo alla rovescia dei tassi negativi e l’investitore nel paese delle meraviglie Secondo il capo economista della Bank of England Andrew Haldane, le cicatrici della crisi scoppiata nel 2008 resteranno sulla nostra pelle per un’intera generazione. Il costo effettivo dei danni provocati all’economia (inclusa la mancata crescita) è quasi impossibile da calcolare con esattezza ma, per avere almeno un’idea, le stime oscillano tra una e sei volte il valore del prodotto interno lordo globale. Ossia tra i 70 mila e i 420 mila miliardi di dollari. Il rischio di un collasso del sistema del credito internazionale, è stato scongiurato soltanto grazie all’intervento di banche centrali e governi con un massiccio impiego di soldi della collettività. Come ha ammesso durante la sua deposizione al Congresso statunitense l’ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan «è crollato l’intero edificio concettuale». Greenspan, che non è esente da responsabilità per quanto accaduto, si riferiva all’idea che mercati deregolamentati e privi di restrizioni potessero assicurare crescita e prosperità. Grazie a Governi (ossia soldi dei cittadini) e banche centrali l’economia ha ripreso a crescere in termini relativamente rapidi, scongiurando il ripetersi di quanto accaduto nel 1929. Tuttavia i postumi della crisi sono tutt’altro che smaltiti. Ci abbiamo fatto l’abitudine ma non bisogna dimenticare che, in questo momento, viviamo in condizioni monetarie del tutto particolari, mai sperimentate prima e che generano situazioni surreali. Se solo una decina di anni fa vi avessero detto che in futuro si sarebbe verificata una situazione in cui chi prende soldi in prestito viene pagato per farlo mentre chi li presta deve pagare per offrire i suoi soldi vi sareste probabilmente messi a ridere. Eppure è esattamente quello che sta accadendo oggi. Molto di quanto abbiamo detto sinora sul normale funzionamento di banche, banche centrali e credito, dev’essere momentaneamente capovolto. Mentre queste righe vengono scritte titoli di Stato e obbligazioni societarie per un valore complessivo di quasi 17 mila miliardi di dollari offrono rendimenti negativi. Questo vuol dire che chi compra uno di questi titoli accetta di ricevere una cifra inferiore una volta che il prestito arriva a scadenza. In paesi come Svizzera, Germania, Olanda o Finlandia, pagano interessi negativi titoli di Stato con durata di oltre 30 anni. Nei paesi del Nord Europa, dove questa tendenza è molto accentuata, alcune banche concedono mutui ipotecari a tasso negativo. Chi chiede un prestito per l’acquisto di un immobile dovrà restituire una somma più bassa di quella iniziale. Al contempo alcune banche iniziano ad applicare tassi negativi sui conti corrente. I clienti pagano la banca per prestarle i loro soldi. Il debitore guadagna, il creditore perde. Tutto alla rovescia. Le ragioni del capovolgimento Gli analisti di Bank of America hanno calcolato che il livello medio dei tassi che si dovrebbe registrare nel 2020 sarà il più basso degli ultimi 5000 anni! Perché ci troviamo in queste condizioni? Dal 2008, per scongiurare una recessione economica globale (le crisi bancarie causano sempre recessioni perché imprese e consumatori ricevono meno prestiti per investire e acquistare), le più importanti banche centrali del mondo hanno inaugurato una stagione di politiche monetarie «non convenzionali». Come da manuale hanno abbassato i tassi di interesse ma hanno anche tirato fuori dal cilindro tecniche teorizzate ma mai sperimentate prima per rivitalizzare l’economia e fuggire dalla deflazione (calo generalizzato dei prezzi). Ridurre i tassi dovrebbe avere un effetto di spinta sull’attività economica. Per diverse ragioni. È più facile concedere e ottenere prestiti, la moneta locale tende a perdere valore nei confronti delle valute estere favorendo l’export, gli investimenti vengono dirottati verso prodotti finanziari più legati alle attività produttive come le azioni delle aziende. Ma una volta che una banca centrale ha abbassato i tassi fino a zero e ancora non è sufficiente? Si scende in territorio negativo, il mondo inizia a capovolgersi. Una delle prime a sperimentare i tassi negativi è stata la banca centrale svedese, da sempre all’avanguardia nelle tecniche di gestione monetaria. Altre sono seguite, quel che più conta lo ha fatto anche la Banca centrale europea. Quando i tassi sono negativi le banche pagano per tenere depositati i soldi (la banca centrale, ricordiamo, è una specie di banca delle banche). Dovrebbero essere così spinte a utilizzare le loro risorse per finanziare imprese e famiglie. Oppure per acquistare titoli di aziende, fornendo risorse al sistema produttivo. In queste condizioni tenere i soldi parcheggiati presso la banca centrale significa perdere denaro. Il Quantitative Easing, quando una banca centrale si gioca il jolly Diverse banche centrali tra cui Federal Reserve e Bce, hanno condotto imponenti programmi di acquisto direttamente sul mercato di titoli di Stato e di obbligazioni societarie (quantitative easing). È una strada alternativa per cercare di ottenere lo stesso risultato di stimolo all’economia e ai prezzi. La banca centrale crea denaro dal nulla e lo usa per comprare i titoli, aumentando la moneta in circolazione. La banca centrale europea ha oggi in portafoglio titoli per circa 4 mila 600 miliardi di euro (2 mila e 600 miliardi in titoli acquistati nell’ambito del Qe). Prima della crisi superavano di poco i 1000 miliardi. Come già visto, più un titolo è richiesto più il suo valore aumenta e il suo rendimento scende poiché si tratta di una cifra fissa calcolata in rapporto al valore del titolo che invece è variabile. L’abbuffata di titoli da parte delle banche centrali ha così contribuito ad abbassare ulteriormente i rendimenti. Gli investitori che comprano questi titoli non sono così folli come potrebbe sembrare. In questa pazzia, almeno a volte, c’è del metodo. I motivi per acquistare un titolo «perdendoci» dei soldi possono essere almeno tre. La prima è la necessità di investire i soldi in modo sicuro, a ogni costo. Il privilegio di investire in asset estremamente sicuri come un titolo di Stato tedesco o svizzero oggi si paga più che in passato. La seconda può essere l’intenzione di non portare i titoli a scadenza ma di rivenderli una volta che il loro valore aumenta, portando così a casa un guadagno. La terza è la convinzione che si prospetti una fase di deflazione che renda il tasso negativo nominale, un guadagno in termini reali. Per esempio, se per un titolo acquistato a 1000 euro ricevo 990 euro dopo cinque anni (−1%) ma nel frattempo il prezzo dei beni è sceso in media del 2%, il potere d’acquisto dei miei 990 euro è superiore rispetto ai 1000 euro di cinque anni fa. Investitori esteri potrebbero giocare anche con il fattore cambi, scommettendo su guadagni legati a un rafforzamento dell’euro nei confronti della valuta del loro paese di residenza. Sorge spontanea un’obiezione: a questo punto perché non tenere soldi contanti «sotto il materasso». Tenere «ferme» somme consistenti è più facile a dirsi che a farsi. Comporta dei rischi e dei costi, soprattutto se le somme sono consistenti. Conto corrente, cassette di sicurezza ecc. si pagano e non sono completamente esenti da rischi. Anche prendendo alla lettera l’espressione… chi si sentirebbe al sicuro con migliaia di euro in casa? Il lato oscuro delle politiche ultra espansive delle banche centrali Il mondo capovolto è potenzialmente molto pericoloso. Le politiche monetarie molto espansive hanno tra i loro effetti quello di spingere al rialzo il valore di tutti gli asset finanziari e immobiliari. È facile che sui mercati si creino «bolle». Ossia che il prezzo cresca non perché il suo valore aumenta ma perché tutti lo comprano nella convinzione che il prezzo continuerà a salire. Poiché questo gioco non può durare all’infinito e prima o poi i prezzi collassano. Le bolle sono pericolose, molto facili da riconoscere con il senno del poi, molto meno quando ci si trova nel mezzo. Spingendo al rialzo il valore di titoli finanziari e case si aiuta soprattutto chi è già benestante. Negli Stati Uniti il 90% delle azioni è in mano al 10% più ricco della popolazione. Si favorisce quindi una divaricazione delle diseguaglianze. Si agevola l’ascesa di forze populiste che, non di rado, hanno la brutta abitudine di scardinare l’autonomia delle banche centrali forzandole ad applicare o mantenere stimoli all’economia anche quando viene meno la necessità di farlo. Ancora. L’appiattimento dei rendimenti, cioè il ridursi delle differenze tra interessi pagati su titoli a breve e lunga durata, mette sotto pressione i bilanci bancari. Una delle principali fonti di guadagno per gli istituti di credito deriva dalla differenza degli interessi pagati sui depositi e quelli incassati dai debitori a cui erogano prestiti a lunga scadenza. Rendimenti depressi distorcono poi la percezione dei rischi. Il livello di interessi non rispecchia la reale pericolosità di un prodotto finanziario. Inoltre sui mercati si scatena una disperata caccia al rendimento. Chi vuole guadagnare è costretto a investire in titoli sempre più rischiosi. Questo vale soprattutto per quei fondi pensione o assicurazioni che offrono prodotti a rendimento garantito (diffusi soprattutto in Svizzera, Germania e altri paesi del nord Europa). Infine lo stimolo dei tassi negativi sull’economia sembra infine affievolirsi nel tempo e oltre una certa soglia. Tassi poco sotto lo zero aiutano, ma l’effetto si riduce nel tempo e si affievolisce man mano che si scende. E, una volta creato un «ecosistema di denaro facile», è molto difficile tornare indietro. Sui mercati si crea una sorta di dipendenza e, se l’economia non è sufficientemente solida, l’interruzione degli stimoli può risultare eccessivamente traumatica. In questo modo le banche centrali finiscono per trovarsi con le mani legate. Questa condizione di stallo può essere risolta solo con un passaggio di testimone. I Governi dovrebbero assumere un ruolo più attivo nel sostegno dell’economia, consentendo così alle banche centrali di farsi gradualmente da parte. Secondo Keynes la politica monetaria è meno efficiente di quella fiscale (investimenti pubblici e riduzione di tasse) nel favorire la crescita. Negli ultimi decenni ha però prevalso una visione delle cose opposte sostenuta in particolare dalla scuola di Chicago che sposa gli insegnamenti dell’economista austriaco Friedrich Von Hayek. La crisi del 2008 ha evidenziato la necessità di trovare un nuovo equilibrio tra queste due impostazioni. Un piccolo calcolo: valore e rendimento di un’obbligazione Vi sarà forse capitato di sentir dire che per un titolo di Stato, o per un’obbligazione societaria, se il rendimento sale il valore scende e viceversa. È corretto ma questa formula può dar luogo a un po’ di confusione. Vediamo esattamente cosa accade. I titoli obbligazionari, o bond, sono detti a reddito fisso. Quando si comprano non si fa altro che prestare soldi a uno Stato o a un’azienda. Questo prestito ha una durata variabile, da pochi mesi fino a trenta anni. Quando questi titoli sono offerti sul mercato viene fissata una cedola il cui valore varia in base all’alta o bassa richiesta. Si tratta dell’interesse che, ogni anno, verrà pagato a chi compra il titolo, più basso se il titolo è molto richiesto al momento del collocamento, più alto nel caso contrario. Questo interesse è espresso in percentuale rispetto al valore del titolo (es. una cedola di 10 euro su un titolo da 1000 euro significa un interesse dell’1%) ma è fisso nel suo valore assoluto (saranno sempre 10 euro). Una volta che il titolo arriva a scadenza, l’acquirente si vedrà restituire lo stesso ammontare di soldi che aveva investito. Avrà però guadagnato gli interessi accumulati negli anni di durata del bond. Nel corso della sua vita, il titolo può essere rivenduto e riacquistato ed è soggetto alle dinamiche di mercato. Se in molti lo vendono, magari perché lo Stato o l’azienda che lo ha emesso sono diventate meno affidabili, il suo prezzo scende. Se in molti lo comprano, accade il contrario. Poiché gli interessi pagati rimangono invariati in valore assoluto, la loro quota rispetto al valore del titolo cambia. Facciamo un esempio. Compro un titolo di Stato quinquennale da 1000 euro che offre un rendimento annuo di 100 euro (10%). Dopo un anno aumenta la richiesta sul mercato di quel titolo e quindi per comprarlo non bastano più 1000 euro ma 1100. Nel frattempo però gli interessi non cambiano, poiché sono fissi. Restano quindi di 100 euro. Rispetto a un titolo che vale 1100, questi interessi non sono più il 10% ma il 9% (approssimato). Il valore del titolo è cresciuto ma il suo rendimento in termini percentuali è sceso. A chi compra un bond per tenerlo fino alla sua scadenza queste dinamiche interessano poco. A scadenza si vedrà restituire esattamente la stessa cifra investita cinque anni prima (all’approssimarsi del termine le dinamiche di mercato che incidono sul titolo si attenuano fino a scomparire). Discorso diverso per chi ha un approccio più speculativo e punta a sfruttare la variazione del prezzo del titolo. O’ spread A Napoli è in vendita un tipo di «botti» di Capodanno battezzato spread. Questo dà l’idea di quanto negli ultimi anni questa parola sia entrata, con prepotenza, nel linguaggio comune. Associata a qualcosa di pericoloso e potente. Lo spread in realtà non è altro che la differenza di rendimento tra due titoli. Quello di cui sentiamo sempre parlare riguarda la differenza tra titoli di Stato decennali italiani e tedeschi. Il titolo tedesco funge da riferimento perché in Europa è considerato il più sicuro, quanto di più prossimo al rischio zero. Se un titolo decennale tedesco rende l’1% l’anno e uno italiano il 3%, il differenziale sarà del 2%. Poiché lo spread è calcolato in centesimi di punto percentuale (punti base) la cifra sarà 200. Lo spread può quindi ridursi e ampliarsi per due ragioni, perché cambia il rendimento italiano o perché si muove quello tedesco o perché si muovono entrambi. Se il rendimento tedesco scende allo 0,9%, lo spread salirà a 210 anche se il titolo italiano non registra variazioni. Perché è importante questo differenziale? Il rendimento di un titolo di Stato cresce quando i mercati percepiscono un aumento del rischio di insolvenza. Ossia la possibilità che il titolo non venga rimborsato, o che lo sia solo in parte. O anche che venga rimborsato con una moneta più debole rispetto a quella con cui è stato emesso (come nel caso di un’ipotetica uscita dall’euro). Risultando più rischioso, al paese vengono chiesti interessi più alti. Se lo spread cresce molto significa che in un paese sta accadendo qualcosa che preoccupa gli investitori. Interessi più alti protratti per lungo tempo significano anche che uno Stato deve spendere di più per pagare i suoi creditori (i possessori dei titoli). Così finanze pubbliche già in difficoltà (altrimenti i mercati non sarebbero preoccupati…) subiscono ulteriori pressioni. Il pericolo è quindi che la situazione si «avviti» e che diventi molto difficile da gestire. Curva rendimenti: mito o realtà La curva dei rendimenti è un grafico che mette in relazione i rendimenti di un certo tipo di obbligazione con la sua durata. In condizioni normali questa curva ha una forma crescente. Più aumenta la durata, più il rendimento cresce. Se la scadenza si allunga infatti ci si priva dei propri soldi per più tempo e cresce il rischio che il prestito non venga rimborsato. Il rendimento chiesto da chi presta è quindi più alto. Questo è il fattore di base che modella la curva ma se ne aggiungono altri. Il primo è il livello dei tassi di interessi praticati dalla banca centrale. Le variazioni influenzano tutta la curva, ma hanno un impatto più forte e immediato sui titoli con scadenze brevi. Su quelli a lunga durata incidono anche le attese sui futuri andamenti economici e sull’inflazione. Questa variabilità degli effetti può portare a un appiattimento o a un’inversione. Invece che salire la curva declina, titoli a breve scadenza rendono quanto, se non di più, di quelli a lunga. Accade facilmente quando gli investitori vedono all’orizzonte un peggioramento delle condizioni economiche e un rallentamento dell’inflazione. Con un’inflazione che si riduce i rendimenti dei titoli a lunga scadenza (dai due ai trenta anni) diventano più interessanti e gli acquisti di questi bond si intensificano. La maggior domanda produce un aumento dei prezzi e una discesa dei rendimenti. Economia in frenata significa anche maggiori probabilità di un futuro taglio dei tassi da parte della banca centrale. Mossa che avrebbe un effetto immediato sui titoli brevi, riducendone i rendimenti. Gli investitori evitano quindi di comprare questi bond, la minor domanda comporta una riduzione dei prezzi e un incremento dei rendimenti. La previsione di un peggioramento dell’economia, spinge quindi verso il basso i rendimenti dei titoli a lunga scadenza e verso l’alto quelli dei titoli a breve. La curva in sostanza non è altro che la sintesi delle aspettative di tutti i soggetti che agiscono sui mercati. L’inversione è il segnale della diffusa percezione di un prossimo rallentamento dell’economia tanto che in passato ha avuto una capacità predittiva non indifferente. I rendimenti dei titoli di stato statunitensi si sono invertiti alla fine degli anni Ottanta, subito prima della recessione causata dallo shock petrolifero. Lo stesso è accaduto, in modo ancora più evidente, prima dello scoppio della bolla Internet del 2001. Anche la crisi finanziaria globale del 2008, e la successiva recessione, sono state precedute da un periodo di inversione dei rendimenti. Esiste tuttavia anche una lettura differente di questo «effetto Cassandra» dell’inversione. Ossia che non si tratti di un semplice sintomo e segnale ma sia causa vera e propria delle recessioni. Tassi a breve più alti di quelli su lunghe scadenze, disincentivano infatti le banche dal prestare soldi a imprese e famiglie, favorendo così un rallentamento del ciclo economico. La capacità predittiva della curva non è comunque infallibile. Giappone, Gran Bretagna e Germania hanno assistito a inversioni dei rendimenti dei loro titoli, senza che sia seguita una recessione. Capitolo 6 Di zanzariere, abiti pesanti e capitali: un racconto sulla globalizzazione Leggendo i capitoli precedenti avete intuito quanto i sistemi finanziari della gran parte dei paesi del mondo siano strettamente interconnessi. I soldi, il credito, la finanza… qui la globalizzazione è arrivata prima che altrove e in modo radicale. Quel che succede a Tokyo ha effetti anche a Londra, quel che accade a Pechino muove la borsa di New York, ciò che viene deciso a Washington cambia la vita di chi abita a Buenos Aires. Il dollaro è la moneta degli scambi internazionali, la valuta di riferimento a livello globale, tanto che il 70% delle banconote da 100 dollari si trova fuori dagli Usa. Le mosse della Federal Reserve, basate sull’andamento dell’economia Usa, producono quindi effetti che vanno ben oltre i confini statunitensi. Non sempre politiche monetarie buone per gli Stati Uniti lo sono anche per gli altri paesi. Se la Fed muove i tassi gli interessati non sono solo cittadini e imprese statunitensi, sono anche governi, aziende e abitanti dei paesi emergenti. Tassi Usa più alti determinano infatti un rafforzamento del dollaro rispetto alle altre valute. Implicano un costo più elevato di prestiti e mutui a tasso variabile e un aumento dei rendimenti per tutti i titoli denominati in dollari. Investire in questi prodotti diventa più allettante mentre il rischio inferiore rispetto a un titolo dei paesi emergenti. Capitali di tutto il mondo vengono quindi attratti verso l’America. Tassi alti, un magnete che risucchia dollari da tutto il mondo Non solo. Non conviene più, o conviene meno, farsi prestare dollari per investirli in altri paesi, dove i rendimenti sono più alti. L’aumento dei tassi Usa ha l’effetto di «risucchiare» dentro i confini nazionali immense quantità di denaro sparse per il mondo. Viceversa quando i tassi si riducono e il denaro abbonda, fiumi di denaro scorrono nella direzione contraria, dagli Usa verso i paesi dove conviene di più investire. La Fed dà e la Fed toglie. A queste alte e basse maree di dollari, che si alzano velocemente e altrettanto rapidamente si sgonfiano, sono stati affibbiati diversi nomignoli. Hot money, denaro bollente, il più noto. Plata dulce, soldi facili, se guardati da paesi emergenti dell’area sudamericana, che spesso hanno subìto duri contraccolpi da queste dinamiche. Immaginiamo di essere un investitore statunitense, in un periodo di tassi bassi, farsi prestare soldi costa poco. Per la stessa ragione i titoli di Stato a stelle e strisce hanno rendimenti bassi, insoddisfacenti per chi è in cerca di guadagni. Ma là fuori… c’è un mondo! Per quanto riguarda capitali e investimenti, un mondo senza confini. Posso quindi usare i dollari per comprare prodotti finanziari di qualsiasi paese. Magari un titolo di Stato di un paese emergente, che è più rischioso, ma che rende 5 volte tanto rispetto a equivalente statunitense o tedesco. Per amplificare le dimensioni dei potenziali guadagni, posso inoltre farmi prestare altri dollari e lucrare sulla differenza tra gli interessi che pago per ottenerli e quelli che ricevo investendoli in titoli esteri. Una strategia che prende il nome di «carry trade». Il rischio aumenta ma, a determinate condizioni, il gioco vale la candela. Il gioco delle valute Se voglio comprare un titolo colombiano, indonesiano, turco o quant’altro, dovrò prima convertire i miei dollari nelle corrispondenti valute locali. Quando gli investitori statunitensi che vogliono questi titoli sono molti, la richiesta di pesos colombiani, rupie indonesiane o lire turche, aumenta sensibilmente. Di conseguenza queste valute si rafforzano nei confronti del dollaro. In questo una moneta funziona come qualsiasi bene, se la domanda aumenta e l’offerta resta invariata, il prezzo cresce. Quando si cambiano soldi si compra un’altra moneta, pagandola con la propria. Fin qui, più o meno, tutto bene. Gli investitori esteri guadagnano mentre i paesi emergenti beneficiano di un ingente afflusso di capitali che suppliscono all’esiguità del risparmio domestico e consentono di spingere l’economia. Governi poco attenti alla sostenibilità delle finanze pubbliche, possono approfittare di questa situazione per emettere titoli di Stato in abbondanza, finanziando così spesa pubblica e debito. Nel migliore dei casi questi soldi sono utilizzati per favorire lo sviluppo del paese. Nel peggiore per comprare consenso grazie a misure assistenziali di corto respiro. In entrambi i casi, almeno nell’immediato, la maggiore spesa pubblica spinge l’economia. Così arrivano ancora più capitali dall’estero, si innesta un circolo virtuoso che fa felici tutti. Almeno per un po’. Fine della festa Immaginiamo che la banca centrale statunitense decida di alzare i tassi. Farsi prestare dei dollari diventa più caro e contemporaneamente investire in titoli di Stato e obbligazioni statunitensi rende di più. La reazione di molti investitori sarà quella di disinvestire da titoli esteri per spostarsi su quelli domestici. Un cambio di strategia che innesca una rapida fuoriuscita di denaro dai paesi emergenti e un contestuale deprezzamento delle valute locali. Il circolo che funzionava a favore delle economie emergenti, inverte il suo verso e diventa distruttivo per economie non sufficientemente «protette». La situazione è particolarmente complicata da gestire in presenza di cosiddetti «peg» (gancio), ossia un legame, più o meno rigido, tra il valore del dollaro e quello di una valuta locale. Un espediente a cui a volte ricorrono le autorità politiche e monetarie dei paesi emergenti, per stabilizzare il valore della loro moneta, arginare l’inflazione e rendere così il paese più attraente per gli investitori. Negli anni Novanta l’Argentina si impegnò a garantire un rapporto 1 a 1 con il dollaro. Impegno facile da rispettare quando c’è molta richiesta di pesos, molto meno se la moneta inizia a svalutarsi e i capitali a uscire dal paese. Cosa che puntualmente accadde. Di fronte a questa situazione una banca centrale può fare due cose. La prima è utilizzare le sue riserve di dollari per comprare pesos. Se le cifre impegnate sono ingenti, il pesos recupera valore nei confronti del dollaro. L’altra opzione è quella di alzare i tassi di interesse. La moneta locale si rafforza ma al costo di effetti collaterali sulla crescita economica. Esiste una terza possibilità che non è di esclusiva competenza della banca centrale: il controllo sui movimenti di capitali. Misura emergenziale, perché raramente riesce a frenare il deflusso di denaro per lunghi periodi. Sui mercati, più che altrove, volere è potere. Sistemi per aggirare vincoli imposti, si trovano sempre. Un altro fattore di rischio per i paesi emergenti sono le obbligazioni che le aziende di paesi emergenti scelgono di emettere in dollari e sotto la giurisdizione degli Stati Uniti. Condizione che rendono i titoli più sicuri e allettanti per gli investitori esteri. Così le imprese possono finanziarsi con maggiore facilità e pagando interessi più contenuti. Tuttavia in questo modo legano pericolosamente i loro destini alle oscillazioni del dollaro. Generalmente si tratta di imprese che realizzano ricavi sui mercati domestici (quindi in valuta locale) mentre devono pagare in dollari interessi e rimborso dei titoli. Quando il cambio peggiora, il peso dei debiti può diventare insostenibile. I piccoli diventano grandi e imparano a difendersi Fino agli anni Novanta i paesi emergenti hanno spesso sofferto i mutevoli umori dei mercati e la «dittatura» delle banche centrali estere. Tutt’oggi ci si interroga se l’interazione senza filtri con i mercati di capitali e le loro violente dinamiche, abbia prodotto più benefici o più danni. Scottati da tante invasioni e fughe di capitali, molti dei paesi coinvolti hanno quindi compreso non solo i vantaggi, ma anche i rischi di un’incondizionata apertura ai mercati internazionali. Hanno insomma imparato a coprirsi bene per fronteggiare repentine tempeste finanziarie. Le crisi dei paesi emergenti si scatenano sempre per il combinato disposto di due fattori: fragilità (finanze pubbliche squilibrate, poche riserve di valuta estera, alto debito) e innesco (movimenti sui mercati internazionali dei capitali). L’economista Rudi Dornbusch che aveva molto studiato questi fenomeni affermava: «In economia, le cose ci mettono più tempo di quanto si creda ad accadere, ma una volta che accadono lo fanno molto più rapidamente di quanto si pensi». Quando una crisi attecchisce in un paese è probabile che si propaghi rapidamente a tutti i paesi che presentano condizioni simili, anche se stanno dall’altra parte del mondo. Il primo passo per alzare delle barriere difensive è stato quindi quello di rendere più solide le finanze pubbliche. Avere alti debiti e conti squilibrati nel mezzo di una crisi finanziaria è come affrontare una tempesta con le vele spiegate. Basta un soffio per perdere la nave. Il secondo passo è stato accumulare ingenti riserve di valuta estera. Fieno in cascina per sopravvivere nelle fasi in cui l’accesso ai mercati è precluso. L’insieme dei paesi emergenti, a esclusione della Cina, deteneva nel 1997 riserve in dollari per 325 miliardi. Nel 2017 erano salite a 2 mila 500 miliardi. Cifra che è pari a oltre tre volte il loro debito estero a breve scadenza. Questi paesi si sono così assicurati un buon tempo di sopravvivenza anche durante le fasi più burrascose sui mercati. Alcuni stati come il Cile hanno optato per un controllo più attento dei capitali in entrata dall’estero. È stato imposto un deposito vincolato per due anni senza interessi presso la banca centrale, pari al 30% degli investimenti. La Malaysia, duramente colpita dalla «crisi delle tigri asiatiche» del 1997, ha vietato a soggetti esteri di richiedere prestiti in valuta locale e imposto un periodo di attesa di un anno per la conversione dei proventi della vendita di asset locali. Non sempre l’insieme di queste misure risulta sufficiente ma sicuramente i paesi emergenti sono oggi più consapevoli dei rischi del «denaro bollente» e meglio attrezzati per maneggiarlo. Per chiudere questo capitolo è opportuno dedicare alcune considerazioni alla Cina. Dani Rodrick, economista critico sull’attuale forma di globalizzazione, riassume l’atteggiamento di Pechino nei confronti di rischi e opportunità dell’apertura ai mercati globali con una metafora di uno studente cinese: lasciate le finestre aperte, ma non dimenticate mai di montarci le zanzariere. La Cina non ha mai creduto nella piena liberalizzazione dei capitali e ha sempre conservato una attenta vigilanza sui flussi di capitale in entrata e in uscita. Con la sua crescita e con le sue dimensioni, il paese sta rapidamente conquistando un ruolo di plasmatore dell’ordine finanziario globale. È verosimile che lo faccia a sua immagine e somiglianza, come ricorda David Lubin, nel libro Dance of trillions. Il sistema attualmente in vigore, incentrato sul dollaro e sulla piena liberalizzazione dei movimenti di capitali, prende forma dopo la Seconda guerra mondiale ed è stato disegnato in base ai desiderata di Wall Street e Washington. Man mano che Cina, India e altri paesi emergenti vedranno crescere il loro potere di condizionamento, è lecito attendersi che l’attuale status quo venga modificato in senso più restrittivo. Capitolo 7 Più ricchi o più poveri? La risposta dell’elefante Quando si parla di distribuzione della ricchezza e andamento delle diseguaglianze la confusione incombe. Esistono innumerevoli statistiche, abbondanza di cifre, non di rado in contraddizione tra loro. Spesso si confondono redditi con patrimoni, accrescendo il disordine della materia. Così due tesi opposte, ossia che la povertà diminuisce e che la povertà, o quanto meno il disagio sociale aumenta, finiscono per essere entrambe sostenibili. Un grafico realizzato dall’economista Branko Milanovic, utilizzando un’infinità di dati, fornisce un aiuto prezioso. È noto come il grafico dell’elefante, per la sua forma che rimanda a quella di un pachiderma con la proboscide sollevata. I dati sintetizzati nella curva riguardano il decennio 1998-2008 ossia il periodo immediatamente antecedente alla crisi finanziaria che possono considerarsi tra quelli più globalizzati della storia dell’umanità. Figura 1: variazioni del reddito a livello globale nel periodo 1988-2008 Fonte: Branko Milanovic, Ingiustizia globlale, Luiss University Press, 2017. Sulla colonna verticale si legge se il reddito è aumentato e di quanto. In orizzontale sono invece riportati i vari decili di reddito della popolazione mondiale. Vale a dire dal 10% che guadagna di meno fino al 10% che guadagna di più. Il grafico ci dice parecchie cose. Innanzitutto che per una larga parte della popolazione globale i redditi sono effettivamente aumentati. In particolare per i primi sette decili, con un picco tra il quinto e il sesto decile che ha visto i propri introiti aumentare di quasi l’80%. Chi c’è dietro questi numeri? Ci sono soprattutto lavoratori di economie emergenti come India, Cina, Vietnam e altri. Persone che partivano da un livello di reddito molto basso che hanno indubbiamente beneficiato del processo di globalizzazione in termini economici. Il grafico mostra però anche come, a partire dal settimo decile, l’incremento dei redditi si riduca rapidamente fino ad azzerarsi. Addirittura, gli appartenenti all’ottavo decile non hanno tratto alcun beneficio reddituale da questo decennio di globalizzazione galoppante. Chi sono? Fondamentalmente tutti i membri della classe media dei paesi economicamente sviluppati, come gran parte della popolazione italiana. Ma la «proboscide» del grafico segnala un’altra cosa importante. Quelli che erano già i più ricchi del mondo (ultimo decile, e in particolare ultimo 1%), hanno a loro volta registrato un’impennata dei guadagni, saliti di oltre il 60%. In altri termini quindi, a livello mondiale, i molto poveri e i poveri sono diventati meno poveri, i ricchi sono diventati più ricchi, per chi stava in mezzo non è cambiato nulla, in termini assoluti. In termini relativi, invece, si sono ridotte le distanze dai più poveri e si sono allungate quelle dai più ricchi. Queste dinamiche spiegano, e in certa misura giustificano, il diffuso aumento del sentimento di incertezza e precarietà della propria posizione che attanaglia grandi fette delle società occidentali. Queste tendenze sono suffragate dai numerosi dati, più o meno spettacolari. Ne citiamo solo un paio particolarmente indicativi. Lo stipendio di un amministratore delegato oggi vale fino a 400 volte quello medio di un suo dipendente. Fino all’inizio degli anni Ottanta questo rapporto non andava oltre 1 a 30. Vale la pena ricordare che secondo Adriano Olivetti, uno dei più illuminati e capaci imprenditori della storia italiana, questo rapporto non avrebbe mai dovuto superare 1 a 10. Un dipendente statunitense deve lavorare 129 ore per acquistare un’azione dell’indice azionario S&P500, il triplo di dieci anni fa. Questo dimostra come la ricchezza degli azionisti, in genere persone già appartenenti alla fascia più benestante della popolazione, sia aumentata molto più rapidamente rispetto a chi può contare esclusivamente sul proprio stipendio. Un eccesso di diseguaglianze non nuoce però solo a chi lo patisce ma anche alla crescita nel suo complesso come dimostrano ormai innumerevoli studi. Sia per l’effetto depressivo sui consumi sia per le tensioni sociali che, prima o poi, finiscono per esplodere. Non è un caso che negli ultimi anni organizzazioni come il Fondo monetario internazionale o l’Ocse, abbiano sottolineato la necessità di arginare l’incremento della distanza economica tra le diverse fasce della popolazione. Sempre meno redistribuzione La dilagante finanziarizzazione dell’economia, e le sue degenerazioni, hanno favorito ulteriormente chi già era benestante, allargando ancora il gap tra ricchi o ricchissimi e una classe media sempre più in difficoltà. Una tendenza che, dagli anni Ottanta in poi, è stata rafforzata dalla progressiva riduzione delle aliquote fiscali applicate alle fasce di reddito più alte e ai profitti aziendali. I 400 statunitensi più ricchi del paese possiedono beni per quasi 3 mila miliardi di dollari, due volte il Pil di un paese dell’Italia ma, proporzionalmente, pagano in tasse molto meno delle loro segretarie grazie a imposte particolarmente morbide sui profitti da investimenti finanziari. Un recente studio condotto da un gruppo di matematici e fisici della Tufts University ha utilizzato un modello matematico che dimostrerebbe come, lasciato a se stesso, un sistema di libero mercato tenda inesorabilmente a evolversi verso una oligarchia con pochi ricchi e molti poveri. Partendo tutti dallo stesso livello di ricchezza e se tutti gli scambi avvenissero in modo sempre corretto, ossia che il prezzo pagato equivale al valore di ciò che acquistiamo, l’equilibrio rimarrebbe inalterato. Ma questo non avviene mai e basta una piccola iniziale compravendita in cui una parte guadagna e l’altra perde, per avviare il percorso verso la polarizzazione della ricchezza, che tende poi ad autoalimentarsi. Non solo, più piccola è la ricchezza di un partecipante agli scambi, più rapido è il calo delle sue risorse. «Niente costa tanto caro come essere poveri», diceva, a ragione, lo scrittore francese Paul Brulat. Non esiste nessun trasferimento di ricchezza dall’alto verso il basso (un assunto su cui è stata costruita la folkloristica teoria dello sgocciolamento o trickle down, secondo cui se lo Stato aiuta i ricchi a diventare ancora più ricchi, in qualche modo finiscono per beneficiarne tutti poiché parte di questa ricchezza sgocciola verso il basso). È vero invece l’esatto contrario: più le disparità si accrescono più aumenta la potenza con cui le risorse vengono attratte verso l’alto. Tasse? Solo in paradiso Come se non bastasse, una parte consistente della ricchezza privata globale è celata in paradisi fiscali, dove le tasse sono bassissime o addirittura inesistenti. Si tratta di cifre talmente imponenti da avere un effetto distorsivo e falsante sulle statistiche ufficiali su ricchezza e povertà. L’organizzazione Tax Justice Network, che indaga regolarmente questi fenomeni, stima che nei paradisi offshore siano stati trasferiti e in parte occultati fino a 32 mila miliardi di dollari di ricchezza privata, tre volte il Pil degli Stati Uniti. Nonostante riforme del segreto bancario, più di facciata che di sostanza, la Svizzera continua a fungere da hub attraverso cui transita gran parte dei capitali privati che, da qui, vengono poi indirizzati verso paesi come Lussemburgo, Isole Cayman ecc. Istituti giuridici come il trust anglosassone, consentono di porre una schermatura tra un patrimonio e il suo possessore, inespugnabile per il fisco. Al di là di molte dichiarazioni di intenti, questo stato di cose è sostanzialmente tollerato. Regolarmente si aggiornano più o meno liste di paesi ma misure concrete per arginare il fenomeno, che devono essere concordate a livello internazionale per risultare efficaci, sono state sinora piuttosto modeste. Globalizzazione,un biglietto di sola andata? Non è detto che i trend di cui abbiamo parlato e, in special modo, una perdita di benessere delle classi medie occidentali a favore di quelle delle economie emergenti siano inarrestabili. O che, addirittura, che non si possano invertire. L’ondata di delocalizzazioni di stabilimenti in paesi dove il costo del lavoro è inferiore, che negli ultimi vent’anni ha interessato i paesi industrializzati, sembra aver superato il suo picco. Anzi, grazie anche alla crescente robotizzazione dei processi produttivi e quindi alla minore necessità di manodopera, molte aziende hanno scelto di riportare a casa le loro fabbriche. Questo fa anche capire come a volte sia molto complesso decifrare in anticipo le conseguenze degli sviluppi tecnologici. «Le persone tendono a sopravvalutare gli effetti delle innovazioni nel breve periodo e a sottovalutarli nel lungo», ha detto il fondatore di Microsoft Bill Gates. La diffusione di robot, automazione e sistemi di comunicazione sempre più potenti potrebbero ridisegnare nuovamente il mappamondo della ricchezza. Non è detto che a perderci siano ancora gli stessi. Capitolo 8 Aziende e bilanci, perché a volte più debiti fai più bravo sei Qualsiasi cosa produca un’azienda è, o dovrebbe essere, una macchina moltiplica soldi. Un meccanismo da cui esce più denaro di quanto ne entri. Se non riesce in questa «magia» o addirittura distrugge valore, prima o poi fallisce, poiché nessuno ha più interesse a metterci del denaro. Perché mai qualcuno dovrebbe investire in una rischiosa attività imprenditoriale, quando può comprare, con tranquillità quasi assoluta, titoli di Stato ad alto rating? L’unico motivo è che il gioco valga la candela. Ossia che il maggior rischio sia compensato da rendimenti superiori a quelli di investimenti meno rischiosi. Quando la macchina moltiplica soldi funziona bene, più denaro riceve, più profitti genera. Se l’impresa è efficiente ha quindi interesse a indebitarsi, emettendo obbligazioni o con prestiti bancari. I guadagni che ottiene saranno superiori agli interessi che deve pagare a chi le presta denaro. Ciò è vero soprattutto quando prendere soldi in prestito costa poco, come in questo periodo. Un’azienda che riduce i suoi debiti anche quando i tassi sono a zero, è un’impresa su cui grava il sospetto che sia capace di far fruttare i soldi. Questo ragionamento va inteso cum grano salis, senza spingerlo alle estreme conseguenze per cui un’impresa potrebbe indebitarsi all’infinito producendo crescenti profitti. Ogni comparto produttivo ha livelli di indebitamento ritenuti ottimali. Tuttavia, se ne cogliamo correttamente il senso, capiamo perché gli analisti finanziari storcono il naso quando si imbattono in società che sono poco indebitate rispetto ai concorrenti. È come se dicessero «potresti ottenere mille e invece ti limiti a ottenere 100, perché? Non sei convinto di poter fare di più? Non sei in grado?» Paradossalmente le azioni di un’impresa con pochi debiti possono essere guardate con sospetto rispetto a quelle di una concorrente più indebitata. Secondo i testi di gestione aziendale «massimizzare i profitti» e premiare gli azionisti è l’unica e sola missione di un’impresa: maximizing shareholder value. L’unica responsabilità sociale di un’azienda è aumentare i profitti. Vedremo nel prossimo capitolo come questo dogma abbia finito con il determinare la diffusione di scelte aziendali scellerate, controproducenti per l’economia nel suo complesso e pericolose per la stabilità del sistema finanziario. Ogni tre mesi alle aziende quotate in borsa vengono pubblicati bilanci trimestrali che eserciti di analisti spulciano mentre l’inchiostro con cui sono scritti ancora non è asciugato. Quello che apprezzano, e quasi pretendono, sono profitti che aumentano, sempre. In tal caso, vale la pena investire in quella società, e questo consigliano ai loro clienti investitori. È una visione miope. Nulla può crescere all’infinito e per raccogliere in futuro bisogna prendersi dei periodi in cui si semina, si concima e si attende. La ricerca spasmodica di continui guadagni fa sì che molte imprese preferiscano affidarsi alle tecniche della finanza piuttosto che allo sviluppo e al miglioramento dei loro prodotti. I soldi vengono usati per fare investimenti speculativi, ricomprare azioni proprie alzandone il valore piuttosto che per la ricerca e lo sviluppo o la creazione di nuovi impianti. Le compagnie aeree fanno utili speculando sui prezzi del carburante, le case automobilistiche con le loro divisioni finanziarie che erogano prestiti a chi compra un’auto, e così via. Nel libro Makers and Takers, Rana Foroohar riporta la definizione della casa farmaceutica Pfizer fornita da un ex consulente della stessa azienda: «una strategia finanziaria in forma di impresa». Mentre gli investimenti per lo sviluppo di nuovi farmaci diminuivano, il gruppo incrementava i profitti grazie a tecniche di elusione fiscale e investimenti finanziari, premiando i suoi azionisti con generosi dividendi. Come è fatto un bilancio Pensiamo a un sacco. Tutti i soldi che un’azienda incassa nel corso di dodici mesi, per lo più vendendo i beni che produce, finiscono in questo sacco: si tratta dei ricavi. Alla fine dell’anno il sacco sarà più o meno pieno ma, d’ora in poi, per arrivare all’ultima voce del bilancio ossia l’utile o la perdita, inizierà a svuotarsi. Se alla fine rimarrà qualcosa l’azienda sarà in utile. Se non rimane nulla sarà in pareggio. Se addirittura bisognerà aggiungere dei soldi per compensare le spese, sarà in perdita o «in rosso», dal colore dell’inchiostro con cui i vecchi contabili evidenziavano le perdite (ora si usano le parentesi). Andiamo con ordine. La prima cosa che bisognerà togliere dal sacco, sono i soldi spesi per costruire quel che è stato venduto. Ossia i costi di produzione, come materie prime, stipendi ecc. Quello che resta una volta che ai ricavi sono stati tolti i costi di produzione, è il cosiddetto Mol, margine operativo lordo (in inglese, con piccole differenze, Ebitda, acronimo di earnings before interest, taxes, depreciation and ammortization). Il Mol è un indicatore molto importante poiché ci dice quanto un’azienda è in grado di guadagnare con la sua attività tipica, ossia fabbricando e vendendo i prodotti in cui è specializzata. Ci sono però altre voci da considerare. L’azienda potrebbe dover pagare degli interessi su prestiti che ha contratto: altri soldi che escono dal sacco. Probabilmente dovrà effettuare degli ammortamenti, ossia la riduzione periodica del valore di alcuni beni (macchinari, edifici, automezzi, softwares) che si consumano con l’uso o diventano obsoleti anno dopo anno. Ancora, un’azienda potrebbe avere fatto investimenti in altre società oppure in attività finanziarie. A seconda di come sono andati potrebbero generare introiti o perdite. Infine, se i risultati sono positivi, la società dovrà pagare delle tasse che andranno sottratte al guadagno. Si arriva così alla voce finale (quel che resta nel sacco): utile o perdita. In alcune annate è possibile che operazioni straordinarie «falsino» il risultato e i conti. Per esempio un’azienda può decidere di vendere una divisione o un immobile, oppure una quota che detiene in un’altra impresa. In tal caso il suo bilancio beneficerà di introiti che nulla hanno a che fare con la sua attività produttiva e che caratterizzano esclusivamente i risultati di quel particolare anno. Un bilancio in perdita potrebbe trasformarsi in un bilancio in utile grazie a una di queste operazioni. A una prima occhiata può quindi apparire che l’azienda sia in salute quando in realtà non è così. Per questa ragione i proventi di queste operazioni straordinarie sono generalmente ben specificati nei bilanci ed è sempre bene tenerne conto per valutare il reale andamento di un’impresa. Quello che abbiamo sinteticamente descritto è il «conto economico». Del bilancio fa parte anche lo stato patrimoniale che descrive da dove arrivano le risorse che usa un’azienda (esempio, capitale proprio, prestiti bancari, obbligazioni) e come sono impiegate. Il conto economico è una fotografia dell’azienda in movimento mentre lo stato patrimoniale un fermo immagine. L’erba del vicino… Per farsi un’idea dello stato di salute di una società è fondamentale confrontare i bilanci degli anni precedenti per capire quali voci stanno migliorando o peggiorando e se questa tendenza sia solida e/o reversibile. Inoltre, è sempre utile paragonare il bilancio di una società a quello dei concorrenti. Per esempio, se voglio fare una valutazione dei conti del colosso petrolifero ExxonMobil sarà utile confrontarlo con quello di Shell, di British Petroleum o di altre grandi compagnie petrolifere. In questo modo è facile capire se un’azienda guadagna più o meno dei concorrenti, se è più o meno indebitata, se gestisce bene o male le sue risorse. Esistono diversi indicatori piuttosto semplici da capire e confrontare che si utilizzano per capire le condizioni finanziarie di un’azienda. Ci limitiamo, nel modo più semplice possibile a ricordare alcune delle voci più note e utilizzate. La prima, a cui abbiamo già accennato, è il Mol (Ebitda) ossia il margine operativo lordo è l’indicatore che più immediatamente fotografa il risultato della gestione caratteristica di un’azienda o core business. È ottenuto sottraendo dai ricavi delle vendite il costo della produzione. Quindi prescinde da tutte le componenti non direttamente inerenti alla tipica attività dell’azienda (finanziaria, straordinarie, fiscali). Si usa il termine lordo perché nel suo calcolo sono inclusi anche gli ammortamenti. Sottraendo gli ammortamenti si ottiene il margine operativo netto o utile operativo. Flusso di Cassa (cash flow): il saldo tra gli incassi (di qualsiasi provenienza, industriale o finanziari) e le uscite di un’azienda. Indica quindi le disponibilità finanziarie su cui può contare l’impresa. Se al cash flow sottraiamo i fondi utilizzati per gli ammortamenti otteniamo il free cash flow. Roe (return on equity): il principale indicatore reddituale di una società. Descrive in quale misura il denaro investito dai soci (capitale o equity) viene remunerato dall’attività dell’impresa. Si ottiene quindi dividendo l’utile netto per il capitale. È l’indicatore che, più immediatamente, segnala la convenienza a investire in una certa azienda. Un Roe allettante offre rendimenti di 3-4 punti percentuali superiori a quelli di un investimento sicuro come un Btp decennale. Il Roe assume particolare importanza nel settore bancario, tra le altre cose su questo indicatore si calcolano i bonus milionari per i manager della finanza. Un Roe elevato è dunque un obiettivo che la dirigenza cerca di perseguire con particolare determinazione. Non è necessariamente un bene. Un Roe alto, e significativamente superiore a quello dei concorrenti, può essere infatti il risultato di scelte di investimento particolarmente aggressive e rischiose andate a buon fine. Per questa volta. Roi (return on investment): come il Roe anche il Roi è una misura di redditività ma questa volta vengono presi in considerazione tutti gli investimenti effettuati nell’azienda, quindi non solo il capitale dei soci ma anche le risorse dei finanziatori (debiti). Si calcola dividendo il reddito operativo (prima quindi che vengano pagati gli interessi ai creditori) per gli impieghi totali dello stato patrimoniale. Se il Roi è superiore agli interessi che un’impresa paga sui suoi debiti significa che all’azienda conviene indebitarsi perché riesce a far fruttare i soldi che ottiene in prestito più di quanto spenda per ottenerli. Pfn (posizione finanziaria netta): la differenza tra i debiti dell’azienda e la liquidità e le attività finanziarie di cui dispone. Indica il livello di indebitamento netto di un’impresa. Un rapporto tra Pfn e Mol è considerato accettabile se uguale o inferiore a 4 (per le aziende del settore utilities si arriva a 5-6 volte). Cioè l’indebitamento netto deve essere al massimo 4 volte il margine operativo lordo (significa tra l’altro che per ripagare tutti i debiti ha bisogno di 4 annualità). Mentre il rapporto tra Pfn e patrimonio non dovrebbe essere superiore a 3. Quando si esagera: a lezione giapponese Da quasi trent’anni l’economia giapponese galleggia in una specie di limbo. La crescita economica è debole, nonostante massicci e prolungati stimoli di Banca centrale e Governo. Eppure, negli anni Ottanta il paese aveva incantato il mondo in vorticosi tassi di crescita, diventando rapidamente la seconda potenza economica del pianeta. Cosa è accaduto? Negli anni del boom le imprese nipponiche godevano di condizioni monetarie più generose rispetto ai loro concorrenti europei o statunitensi. Il ricorso al debito era quindi più spinto che altrove. La crescita prolungata favorì anche l’impennata dei prezzi di vari beni tra cui azioni o immobili residenziali e, soprattutto, commerciali. Le aziende avevano investito in modo massiccio in immobili, stabilimenti e altro. Indebitarsi costava poco e i prezzi di questi asset continuavano a salire ripagando ampiamente i costi dei debiti accesi per il loro acquisto. Negli anni Novanta però queste «bolle» esplodono fragorosamente. Nel corso di quel decennio il valore degli immobili commerciali precipita di circa il 90%. Quello che valeva 1000, dieci anni dopo vale 100. Ma un’impresa che si è indebitata per comprare un immobile che vale 1000, dovrà ripagare questa cifra anche se nel frattempo il valore del bene si è ridotto a un decimo. E quando il valore dei debiti di un’azienda supera quello dei beni in suo possesso, si configura sostanzialmente una situazione di bancarotta. Se questo fenomeno si verifica a livello esteso, quasi generalizzato nel caso giapponese, le conseguenze per l’intera economia diventano pesantissime. Paradossalmente il disastro avviene mentre le imprese giapponesi continuano ad avere successo sui mercati internazionali, come mostrano con chiarezza i dati sull’andamento dell’export del periodo. Si tratta di produttori in teoria molto sani che presentano però dei bilanci da società in stato fallimentare, a causa del crollo del valore dei beni che possiedono. Cosa fanno a questo punto le aziende giapponesi? Usano tutti i soldi che guadagnano non per investire o distribuire ricchezza ma per ripagare i loro debiti e riportare in equilibrio i bilanci. Una scelta razionale e opportuna se si considera il singolo caso. Un comportamento devastante per l’intera economia se sono in molti ad adottarlo contemporaneamente. Se la gran parte delle aziende segue questa strategia, gli investimenti precipitano, le imprese non spendono e la domanda aggregata del paese crolla. Si spalancano le porte alla recessione. Per di più, la banca centrale può fare poco. In una situazione di questo tipo per quanto la banca offra denaro a costo basso, nullo o persino negativo, nessuno o pochissimi hanno interesse a prenderlo in prestito. Anzi. La priorità delle aziende è diventata ripagare i debiti e non più massimizzare i profitti. Un apparente controsenso, in un contesto di tassi a zero. E, soprattutto, una situazione da cui il Giappone non è sinora riuscito a riprendersi pienamente. Se a indebitarsi è lo Stato, quando è troppo? Viviamo anni in cui i debiti pubblici a livello globale stanno aumentando. Gli stati si indebitano perché conviene farlo. Questa tendenza desta delle preoccupazioni ma a differenza di un’azienda o di un individuo uno Stato ha diversi assi nella manica per far fronte ai suoi debiti e agli interessi che deve pagare ai creditori. Ciò rende particolarmente complesso stabilire quando un debito pubblico è davvero eccessivo. Uno Stato può banalmente alzare le tasse e spremere cittadini e imprese ottenendo più denaro per pagare gli interessi. C’è anche un modo più furbo e mascherato per ottenere lo stesso risultato: stampare moneta. Una strada facile da seguire in paesi dove la separazione tra governo e autorità monetarie non è netta e rigorosa. Stampando moneta si genera però inflazione, quindi ciò che i cittadini guadagnano diminuisce in termini reali. Ci potranno essere degli adeguamenti ma raramente terranno il passo dell’aumento dei prezzi. Al contempo però il peso reale del debito diminuisce. In sostanza, ancora una volta, il conto lo pagano i contribuenti ma è più difficile rendersene conto rispetto a un aumento delle imposte. Questo non esclude che anche gli stati possano fallire. Sostanzialmente che non siano più in grado di ripagare i loro debiti. O che scelgano deliberatamente di non farlo, poiché, a conti fatti, può essere la soluzione più conveniente. La storia è piena di default di stati sovrani più o meno traumatici. Sono decisioni in cui la politica si mischia strettamente con l’economia quindi non sempre del tutto decifrabili da un punto di vista esclusivamente finanziario. Ma a causa delle caratteristiche peculiari del soggetto Stato è particolarmente arduo stabilire quando il livello di debito sia eccessivo. Il Giappone sostiene senza troppi problemi un debito che è pari al 200% del suo Prodotto interno lordo, sensibilmente più alto di quello italiano che si ferma al 130% del Pil. L’Ucraina ha dichiarato default su un debito che era appena il 30% del suo Pil, la metà di quel 60% ritenuto, un po’ arbitrariamente, dai trattati fondativi dell’Unione europea un valore ottimale. In linea di massima possono valere due considerazioni generali. Sono più a rischio paesi che fanno forte affidamento su finanziamenti esteri. Il debito giapponese è per esempio in larghissima parte detenuto da investitori domestici. Un debito pubblico inizia inoltre il suo cammino verso l’insostenibilità nel momento in cui la spesa per gli interessi inizia a salire al di sopra di ciò che rimane una volta che agli introiti dello Stato vengono sottratte le spese (avanzo primario). Capitolo 9 Risparmio e investimenti, meglio non da soli (nonostante tutto) La stampa finanziaria abbonda di cifre e aneddoti sui deludenti risultati dei gestori di risparmio professionisti. Sono stati messi a confronto con le performance di investitori improbabili come maghi o bambini di sei anni. È stato anche fatto un paragone con i risultati raggiunti scegliendo le azioni con il lancio di freccette. Non di rado i gestori perdono. Spezziamo una lancia a loro favore: investire e fare meglio del mercato nel suo insieme è molto difficile e richiede la disponibilità ad assumersi qualche rischio in più. Cerchiamo di capire perché. Se guardate un’azione vedete un’azienda e un prezzo. Quello che non vedete è la gigantesca mole di informazioni che quel prezzo racchiude e sintetizza. Il valore di ogni titolo dipende infatti dal bilancio dell’azienda, dai suoi guadagni o dalle sue perdite presenti e previste in futuro, dal confronto con i concorrenti, dalle prospettive di crescita che sembra avere, da fattori economici, politici e sociali che potrebbero influenzarle, dalla qualità dei suoi manager e da molto altro ancora. Eserciti di analisti professionisti e potenti computer lavorano senza tregua per provare a stabilire il valore corretto per ogni titolo in un preciso momento. Come segugi cercano continuamente scostamenti al ribasso o al rialzo rispetto al prezzo reputato corretto. Se trovano una di queste incongruenze ne approfittano vendendo o comprando. L’informazione sull’errore viene così trasmessa al mercato che reagisce pressoché all’istante provocando il riallineamento del prezzo del titolo. Tutto avviene in modo incredibilmente veloce, a maggior ragione oggi con scambi totalmente automatizzati e in larga parte gestiti da algoritmi. Oltre il 60% degli scambi avviene in modo automatico in base a decisioni assunte da computer. Ciò non vuol dire che i mercati abbiano sempre e comunque ragione, e che i valori azionari siano sempre quelli esatti. Il più delle volte però è così e, fondamentalmente, i prezzi riflettono in modo accurato l’influsso di innumerevoli fattori. Market knows best, il mercato lo sa meglio, è una formula su cui è stato fatto esagerato e cieco affidamento ma che contiene del vero. Effetto sorpresa Questa sorta di saggezza e onniscienza dei mercati è anche la ragione per cui i valori azionari non si muovono, o lo fanno pochissimo, di fronte a notizie attese e prevedibili. Per fare un esempio, se il dato sulla crescita economica di un paese risulta in linea con le previsioni, in Borsa non succede quasi nulla. Questo dato era già «incorporato» nei prezzi. Al contrario, se il dato sorprende nel bene o nel male, i listini azionari avranno una reazione più significativa. Per chi investe non importa poi tanto se le cose vanno bene o male, conta piuttosto se vanno meglio o peggio di quanto si pensasse. In fondo non è diverso da ciò che accade in altri ambiti. Se ci fosse una partita Campioni contro Riserve, scommettere sulla vittoria dei primi avrebbe probabilità di successo molto elevate ma con un guadagno ben misero, visto che si tratta di un risultato prevedibile. Al contrario puntare sulle Riserve (magari perché sono convinto che ci sia un fenomenale attaccante incompreso dagli altri) mi garantirebbe, nel caso di un’inattesa vittoria, la vincita di una somma ragguardevole. Per guadagnare più del mercato bisogna insomma indovinare o capire qualcosa che tutti gli altri non hanno visto. Quattro le strade: talento sconfinato (rarissimo), livello di analisi e implementazione di strategie superiore (raro), fortuna (bendata), informazioni privilegiate (illegale). I non più giovanissimi ricorderanno forse come fosse in questo modo che il finanziere Gordon Gekko nel film Wall Street di Oliver Stone accumulava la sua ricchezza. Per descrivere il comportamento di un investimento speculativo John Maynard Keynes utilizzò la metafora del concorso di bellezza. La bravura di un investitore non è quella di individuare la ragazza più bella (l’azienda più sana) ma di indovinare quale ragazza raccoglierà la preferenza di più giurati (il titolo su cui si concentreranno più acquisti). Cifre impietose Il fatto che fondi e gestori possano fare meglio del mercato solo raramente è il segreto di Pulcinella su cui prospera l’industria del risparmio gestito. I dati però parlano piuttosto chiaro. In un confronto decennale, tra il 70 e il 90% dei fondi azionari mostra risultati peggiori dei listini. Battere il mercato può essere incredibilmente difficile. Per spiegare quanto, sono utili le parole importanti dell’affermato investitore statunitense come Bernard Baruch: «Se sei pronto a rinunciare a tutto il resto e studiare a fondo la storia e i precedenti del mercato e tutte le principali aziende le cui azioni sono in vendita, con la stessa attenzione che uno studente di medicina dedica all’anatomia, se riesci a fare tutto ciò e inoltre hai i nervi d’acciaio di un giocatore d’azzardo, il sesto senso di un chiaroveggente e il coraggio di un leone, forse hai una minima chance». È dunque meglio affidarsi al caso? Mettersi a tirare freccette per scegliere i titoli da comprare? Se fossimo davvero capaci di farlo, forse sì. Ma la nostra mente non è capace di affidarsi davvero al caso. Agisce, anche quando dispone dei soldi, seguendo percorsi complicati, non di rado tortuosi e, purtroppo, a volte controproducenti. Quanti di noi, in fondo, sarebbero davvero disposti e avrebbero l’audacia di investire denaro a caso? Quanto sappiamo farci male da soli Le dinamiche psicologiche che determinano scelte di investimento sono molto studiate. Da anni esiste una disciplina specificatamente dedicata a questo compito chiamata finanza comportamentale. L’aspetto fondamentale è che le nostre decisioni tendono a essere guidate da istinto ed emotività più che dalla ragione. Sviluppiamo così abitudini nelle scelte che si rivelano spesso controproducenti. La prima è quella di «investire con lo specchietto retrovisore», ossia in base a quello che è successo in passato. Se con un certo investimento abbiamo guadagnato, sottovalutiamo il rischio di perdite e tendiamo a ripetere la stessa scelta. Se abbiamo perso, succede l’opposto: sopravvalutiamo i rischi e non valutiamo oggettivamente le chances di profitto. In ogni ambito subiamo il cosiddetto effetto gregge, tendiamo ad agire come gli altri. In un’ottica biologica ed evolutiva ha un senso e, entro certi limiti, può funzionare anche nella gestione del risparmio. Trend is your friend except at the end, recita in fondo un vecchio adagio dei mercati: la direzione in cui si muovono i mercati è tua amica, tranne quando sta per cambiare. In altri termini quando un titolo o un listino consolidano una fase di crescita, è verosimile che continuino a salire per un po’. Non fosse altro che per il semplice fatto che un mercato in crescita attira il «gregge» degli investitori che, investendovi, lo fanno salire ancora. Il problema è capire fin quando può durare (Time is the enemy). Quando ci facciamo trascinare dal gruppo, è facile perdersi il meglio perché si arriva tardi. L’effetto gregge poi mostra i suoi risvolti più deleteri nelle fasi di crollo dei mercati: tutti si affollano all’uscita rischiando di rimanere, metaforicamente, schiacciati. Per gli investitori più freddi ed esperti queste sono invece occasioni d’oro per fare incetta di titoli sottovalutati. Sbagliamo la tempistica anche quando un titolo che abbiamo in portafoglio perde valore. Ci convinciamo che prima o poi recupererà il prezzo a cui lo abbiamo acquistato. Ma questa garanzia non esiste e avrebbe più senso vendere titoli in perdita e tenere quelli che stanno guadagnando. Come se non bastasse, quando ci si forma un’opinione su qualcosa (es. la Aerospazio Spa è un buon titolo), prestiamo attenzione solo alle notizie e le informazioni che confermano questa convinzione, tralasciando di dare il giusto peso a indicazioni di segno opposto. Al di là di qualsiasi ragione finanziaria concreta preferiamo poi acquistare titoli che hanno a che fare con il nostro paese. Per noi italiani Bot, Btp e/o azioni quotate sulla Borsa italiana. «Mogli e bond dei paesi tuoi», insomma. Niente garantisce però che questa sia una scelta vantaggiosa per i nostri risparmi, così come per le mogli. Diverse indagini hanno poi mostrato che meno sappiamo di finanza e investimenti, più siamo convinti di saperne (atteggiamento peraltro che non riguarda solo l’ambito finanziario come può facilmente rendersi conto chiunque entri in un bar animato). Un fenomeno chiamato overconfidence (eccesso di confidenza) molto pericoloso quando investiamo il nostro denaro. È stato studiato persino l’effetto che hanno alcuni medicinali sulle scelte di investimento. L’uso di benzodiazepine (presenti nei più comuni ansiolitici) provocano, per esempio, un aumento della propensione al rischio. Nelle situazioni di grave crisi finanziaria sembra addirittura che le decisioni vengano dettate da circuiti celebrali che si attivano per fronteggiare la paura. Un meccanismo pressoché identico negli uomini e nei topi. Esperienze dolorose del passato, vissute personalmente o apprese da altri, guidano subdolamente le nostre scelte. Un sistema che funziona quando ci troviamo davanti un leone, o un gatto, affamato. In questi casi conta agire all’istante, bypassando il ragionamento. Ma non certo la tecnica più adatta quando dobbiamo decifrare le ragioni di un calo dei listini. Tra il dire e il fare… C’è un’ultima ma cruciale ragione per cui è difficile fare da soli. Come sottolineano molti gestori di hedge funds (fondi riservati a investitori facoltosi che utilizzano tecniche d’investimento particolarmente sofisticate), l’aspetto fondamentale di un investimento di successo è il modo in cui viene implementato. Una buona idea non basta, bisogna sapere come metterla bene in pratica. Quali strumenti finanziari utilizzare. A volte è relativamente semplice, a volte tecnicamente complesso e fuori dalla portata di chi non è professionista. Questione di attimi Quanto velocemente accadono le cose sui mercati? Molto più di quanto si possa immaginare. Oggi circa i due terzi degli scambi sono gestiti da algoritmi che «girano» su computer sempre più potenti. In millesimi di secondi un computer può ordinare di acquistare, vendere e ricomprare titoli per milioni di euro, guadagnando su microscopiche differenze di prezzo. Società d’investimento specializzate in questo tipo di transazioni stabiliscono le sedi vicino alla Borsa, per ridurre di frazioni infinitesimali il tempo con cui un ordine che parte dai loro computer arriva a quello della piazza finanziaria. Chi arriva prima vince. Città che vogliono attrarre operatori della finanza devono poter contare sulle reti digitali efficienti, meglio se direttamente connesse alle dorsali principali su cui viaggiano dati e informazioni. Tecniche di questo tipo, impostate sulla velocità di esecuzione piuttosto che sulla valutazione delle caratteristiche di un’azione, fanno sì che, nel breve periodo, le oscillazioni di titoli e listini siano sempre meno collegate ai cosiddetti «fondamentali». Vale a dire alle performance, lo stato di bilancio e le prospettive di crescita. Esistono ormai algoritmi in grado di «fiutare» l’arrivo di grandi ordini. Quando si muove un grande fondo gli acquisti su un determinato titolo possono essere nell’ordine delle centinaia di milioni di euro. Ma il computer che riceve il maxi ordine non lo processa in un’unica soluzione ma lo suddivide in pacchetti. Così via via che la sequenza di acquisti si perfeziona, il prezzo del titolo inizia a salire. L’algoritmo capisce cosa sta accadendo e immediatamente si «infila», ordinando a sua volta l’acquisto del medesimo titolo. Poiché il prezzo continuerà a salire finché l’esecuzione del maxi ordine sarà completata, i guadagni sono pressoché certi. È un gioco che ovviamente non piace ai grandi investitori che effettuano questi grandi ordini e che così ci rimettono dei soldi. Più soggetti si aggiungono «in scia», più il prezzo del titolo sale mentre l’acquisto si completa. È per questa ragione che sono nate le cosiddette «dark pool», mercati alternativi, gestiti da grandi banche e con una sorta di selezione all’ingresso, in cui si possono vendere e comprare titoli senza eccessive interferenze esterne. Nel mondo della finanza c’è però un’incorreggibile tendenza a farsi prendere la mano. Così queste dark pool, meno regolamentate e meno controllate, sono diventate il luogo dove realizzare le compravendite più spericolate su prodotti altamente rischiosi. Una borsa per robot e computer? Che ruolo possiamo avere noi umani in questo mondo ipertecnologico sempre più gestito in autonomia da computer? Esistono ormai, in tutti i campi, programmi che apprendono e si migliorano da soli, quindi la sapienza e la capacità di gestire gli investimenti di questi operatori artificiali è destinata a divenire sempre più approfondita. Il cervello umano però ha capacità incredibili. Nel 2012 l’ex trader di Goldman Sachs e JP Morgan, John Coates, ha dedicato il libro The hour between dog and wolf alla velocità stratosferica con cui funzionano i mercati e al ruolo dell’uomo in questi ingranaggi. Alla sua capacità di adattamento e alle reazioni fisiche e mentali di fronte allo stress. Il libro, supportato da indagini mediche e psicologiche, dimostra come ci siano alcuni meccanismi di reazione umana che poco hanno da invidiare ai computer in termini di velocità di reazione e capacità di cogliere in anticipo i segnali. Accade perché gli eventi accaduti in passato vengono conservati in memoria associandoli a sensazioni e reazioni somatiche. Prima ancora che nella nostra mente si disegni chiaramente la percezione, che qualche evento sta per ripetersi, il nostro corpo anticipa questi accadimenti inviando segnali. Maggiori sono le situazioni di mercato che sono state memorizzate, più si sviluppano le capacità di reazione immediata. Inoltre un conto sono gli scambi istantanei sul mercato, un altro è impostare strategie di lungo termine calibrate alla luce di fattori non solo economico-finanziari ma anche di evoluzioni sociali, geopolitiche, demografiche. Le regole del gioco cambiano totalmente, la velocità conta poco mentre l’esperienza di chi investe diventa fondamentale. Clamorosi fallimenti del mercato Le bolle speculative sono uno dei fenomeni più spettacolari del mondo della finanza. Non sorprende che abbondino i libri di storia dell’economia dedicati a questo argomento. Il passato è ricco di vicende suggestive. Dalla citatissima bolla dei tulipani nell’Olanda del Seicento, quando i bulbi di alcuni fiori venivano scambiati al prezzo di un’abitazione, alla recente bolla Internet o a quella dei prezzi immobiliari. Cambiano le epoche, cambiano le circostanze, cambiano i protagonisti ma il meccanismo è più o meno sempre lo stesso. Un alito di follia mascherato da ragione, si insinua in quel regno della razionalità che illusoriamente si suppone che siano i mercati. Un soffio che attecchisce, contagia e si diffonde. Vola sull’erronea convinzione che il prezzo di un bene continuerà a salire, perché così accade da tempo. Per giustificare questa convinzione c’è sempre un qualche appiglio razionale, almeno all’inizio. Prendiamo il caso della bolla Internet. Alla fine degli anni Novanta la diffusione della rete e delle possibilità di sviluppo di business che portava con sé, innescò una corsa dei prezzi di qualsiasi azione avesse a che fare con il web. O che semplicemente utilizzasse il suffisso .com. Alla base di questa corsa c’era un’assunzione corretta, ossia la percezione del potenziale rivoluzionario delle nuove tecnologie. Tuttavia lo scenario era ancora fumoso, si intravedeva una strada ma nessuno sapeva con esattezza dove avrebbe portato. Il Nasdaq, listino statunitense che all’epoca ospitava quasi tutti i principali titoli Internet, prese il volo. Il 14 marzo 2000 superò i 5000 punti. Un anno dopo ne valeva meno di 2000, una perdita di oltre il 60%. A Piazza Affari la società Tiscali era arrivata a valere più del gruppo Fiat. Si era diffusa una mania irrazionale in cui gli investitori compravano solo per la convinzione che i prezzi sarebbero saliti ancora, perché «questa volta è diverso». Ma, per quanto possiamo essere abili a convincerci del contrario, diverso non lo è mai. Prima o poi la realtà presenta il conto alle illusioni. La finzione per cui società che valgono 10 ma vengono valutate e vendute a 100 o 1000 si sgretola. I più accorti fiutano che la festa è finita. Iniziano a vendere. Il meccanismo che aveva innalzato i titoli su valori stratosferici inizia a funzionare alla rovescia. Si vende tutto indiscriminatamente il più in fretta possibile, nella convinzione, altrettanto errata, che i prezzi non possano far altro che scendere. Paradossalmente è proprio in queste situazioni che gli investitori più freddi e accorti possono fare i migliori affari. Lo scoppio di una bolla è come un’ondata che trascina tutto verso il basso, ma una volta che è passata, molte azioni hanno prezzi sottovalutati rispetto al loro potenziale di crescita. Sarebbe il momento migliore per comprare. Il menù dell’investitore Oggi si possono acquistare e vendere, anche dal proprio pc, un’infinità di titoli. Riassumiamo brevemente le caratteristiche dei prodotti principali. Le azioni sono quote di una società. Chi le compra diventa socio, ossia proprietario di una quota più o meno grande dell’impresa. Pertanto partecipa a tutti gli effetti al rischio di impresa. Si può guadagnare molto, ma si può anche perdere tutto. Le azioni sono classificate in base a svariate caratteristiche: bancarie, assicurative, petrolifere, industriali, tlc, lusso, utilities, automobilistiche ecc. Alcuni settori (es. bancario e industriali) sono considerati ciclici, ossia che si muovono con l’economia, vanno bene nelle fasi di crescita e patiscono le fasi recessive. Altri come le utilities (fornitura di servizi come gas ed energia elettrica) sono «difensive» poiché i loro prezzi risentono meno delle fasi economiche. Giuridicamente diverse le obbligazioni che sono un prestito fatto alle aziende o agli stati che le emettono. Chi le compra quindi non è un socio ma un creditore, con annessi vantaggi in caso di fallimento della società. L’obbligazionista viene ricompensato con interessi ma non partecipa direttamente all’eventuale aumento degli utili e del valore della società. Obbligazione vuol dire tutto e niente. Le tipologie di titoli, e il relativo livello di rischio, sono infatti amplissime. Si va da titoli «a prova di bomba» come i titoli di Stato con cui l’obbligazionista presta soldi a paesi come Stati Uniti o Germania, a obbligazioni estremamente rischiose come i titoli di paesi emergenti o di società fortemente indebitate. Più aumenta il rischio più sale l’interesse che il debitore riceve. Prestare i soldi a chi è meno affidabile comporta sempre un «premio» per chi accetta l’azzardo. Senza comprare direttamente titoli, esistono innumerevoli fondi comuni di investimento specializzati per tipologia di prodotti, comparto, area geografica ecc. Chi li gestisce si fa pagare commissioni più o meno laute. In alternativa gli Etf sono fondi che si limitano a replicare la composizione di un determinato indice, senza essere gestiti attivamente e quindi con costi molto più ridotti. Capitolo 10 Verso una nuova crisi? Ci muoviamo inesorabilmente verso una nuova crisi finanziaria, forse persino peggiore della precedente? A temerlo sono in molti e per diverse ragioni. La più evidente è che quella scoppiata nel 2008 fu una crisi dovuta a un eccesso di debito, in particolare nel settore immobiliare statunitense. E come sono state curate questa crisi e questa recessione? Facendo più debito, questa volta soprattutto a carico di aziende e governi. Nel caso dei debiti pubblici molta parte dell’aumento è riconducibile alle spese per il salvataggio di banche, assicurazioni e aziende private. La storia insegna che quasi sempre i grandi disastri economicofinanziari sono preceduti da un aumento del debito, soprattutto quello che grava sulle famiglie. Il debito pubblico e privato a livello globale supera ormai i 250 mila miliardi di dollari, record storico, ed è in continua crescita. Solo i governi sono indebitati per 70 mila miliardi di dollari. Una cifra analoga riguarda le istituzioni finanziarie. I rimanenti 110 mila miliardi fanno capo a famiglie e aziende. Nel 2006 il debito delle aziende Usa ammontava a 5 mila e 700 miliardi di dollari, oggi supera gli 8 mila miliardi. Il contesto di denaro a costo zero favorisce questa corsa all’indebitamento. Inoltre il sistema giuridico, soprattutto statunitense, tende a favorire fiscalmente le aziende che si indebitano. Dimmi perché lo fai Il dato sul valore del debito è importante ma altrettanto importante è capire perché ci si indebita e quanto siano affidabili i debitori. Purtroppo le grandi aziende non si stanno indebitando principalmente per crescere, sviluppare nuovi prodotti o migliorare la loro efficienza. Lo fanno semplicemente perché conviene nell’ottica di operazioni finanziarie. Nel 2016 Apple, tra le prime aziende al mondo per valore di borsa e macchina macina utili che siede su una montagna di denaro liquido, ha chiesto un prestito di 18 miliardi di dollari. Questi soldi, di cui l’azienda non aveva bisogno, sono stati usati per un’operazione di buyback, ossia per il riacquisto di azioni proprie in Borsa. Con operazioni di questo tipo si fa aumentare il valore di un titolo a beneficio dei soci che li possiedono. Quello di Apple è solo uno degli esempi più eclatanti, la moda dei buyback dilaga. Spesso il valore delle azioni sale più per questa ragione che per i reali risultati di un’azienda. È un modo artificioso di creare ricchezza di cui beneficiano esclusivamente gli investitori. Per avere un’idea delle dimensioni di ciò di cui stiamo parlando, tra il 2005 e il 2015 le imprese dell’indice S&P 500 che raggruppa le prime 500 aziende statunitensi, hanno destinato al riacquisto di azioni 4 mila miliardi di dollari, oltre la metà dei loro profitti. I manager dei grandi gruppi sono spinti dai loro grossi azionisti a condurre queste operazioni. Ciò che si ottiene è però un completo capovolgimento della funzione dei mercati finanziari. Dovrebbero essere un canale che convoglia denaro verso le aziende, fornendo loro i mezzi per crescere, sviluppare nuovi prodotti e nuove tecnologie, fare ricerca, con ricadute positive per l’intera economia e collettività. Sono invece diventati una sorta di sistema dittatoriale che impone alle aziende di utilizzare tutto quel che riescono a ottenere con la loro attività industriale a beneficio immediato degli azionisti. Una sorta di avida divinità che pretende continui sacrifici. Questo stato di cose è la degenerazione di quel principio partorito dalla scuola di Chicago e affermatosi negli anni Ottanta, secondo cui l’unico e solo obiettivo di un’impresa è la massimizzazione degli utili dei suoi soci. Un modello che ha condotto a distorsioni pericolose ma che solo ora inizia a essere timidamente messo in discussione. Ma queste condizioni del credito sono destinate a durare in eterno? I mercati si stanno comportando come se fosse così. Ma nel momento in cui le banche centrali dovessero iniziare a rialzare i tassi e stringere le condizioni monetarie per chi ha molti debiti sarebbero dolori. Si capisce quindi come questa spirale di continua crescita dell’indebitamento tenda a perpetuarsi da sola. Più i debiti sono alti, più è difficile per una banca centrale ritornare a politiche monetarie normali. Più le condizioni monetarie rimangono estremamente espansive, più il debito continua ad aumentare. E così via. Non è un caso che alcuni analisti parlino di infinity Qe, il quantitative easing. Una strada che una volta presa non consente di tornare indietro ma che nessuno sa dove possa condurre. Arrivano gli zombies Condizioni monetarie estremamente favorevoli protratte a lungo creano, come abbiamo visto, pericolose distorsioni. Tra queste c’è anche la sopravvivenza di imprese decotte, le cosiddette «zombie companies», aziende tecnicamente defunte ma che continuano a camminare. Sono industrie che guadagnano meno di quel che spendono per pagare gli interessi sul loro debito. Quindi cosa fanno? Emettono ancora più debito per pagare interessi e rimborso. Sempre più appesantite restano però in vita. Possono farlo perché le condizioni sono favorevoli e ci sono investitori alla disperata ricerca di rendimenti, disposti a sottoscrivere obbligazioni anche di aziende «morte» per qualche punto percentuale in più di interesse. Queste società che si trascinano barcollanti hanno il difetto di assorbire risorse dal sistema senza poi utilizzarle a fini produttivi. Come ogni zombie che si rispetti infettano ciò con cui vengono a contatto: fornitori, creditori ecc. Non forniscono apporti alla crescita economica, anzi rubano risorse ad aziende più sane che invece potrebbero farlo. I «leveraged loans», prestiti concessi a società già fortemente indebitate, sono in continua crescita, raddoppiati negli ultimi dieci anni. Oggi negli Stati Uniti valgono 1200 miliardi di dollari (poco meno del Pil italiano). In Europa 270 miliardi di euro ma in costante aumento. Onestamente, chi può davvero dirlo? Gli indizi che lasciano presagire la possibilità di una nuova grave crisi, come abbiamo visto, non mancano. Ma non sono sufficienti per un giudizio certo. Se diciamo che prima o poi arriverà una tempesta, siamo certi che un giorno potremo dire di averci visto giusto. Così però è davvero troppo facile. Secondo uno studio del Fondo monetario internazionale gli economisti hanno sbagliato a prevedere tempistiche e intensità di 148 delle ultime 150 recessioni che hanno interessato 60 paesi. La storia dell’economia è ricca di aneddoti su previsioni clamorosamente sbagliate. Irvin Fisher, professore a Yale, era uno dei più autorevoli economisti della sua epoca, ma oggi ci si ricorda di lui soprattutto perché due settimane prima del crollo del 1929 affermò che «il mercato aveva raggiunto un livello elevato ma duraturo». Nel 2006 l’ex governatore della Federal Reserve, Alan Greenspan, affermò che per la crisi dei mutui subprime il peggio era passato. Nel frattempo, il premio Nobel Joseph Stiglitz certificava la solidità di Fannie Mae e Freddi Mac, agenzie parastatali per l’erogazione di mutui, tra i principali protagonisti del disastro del 2008 finite in bancarotta. Si potrebbe continuare, ma quel che conta è la lezione che si può trarre da questi errori. L’economia non è una scienza esatta, troppe variabili, troppi fattori imprevedibili e non misurabili contribuiscono a determinarne l’evoluzione. Quindi le capacità previsionali sono al momento oggettivamente ridotte e non riconducibili a modelli matematici che, negli ultimi anni, hanno mostrato di funzionare molto bene nella teoria ma molto male nella pratica. Ciò nondimeno, qualche lezione dal passato si può trarre. L’inganno in cui regolarmente si cade per autoconvincersi della sostenibilità di evidenti eccessi è che, per qualche ragione, «questa volta è diverso». Invece non lo è mai stato e il conto è sempre arrivato. Probabilmente arriverà anche questa volta. Capitolo 11 Coronavirus, il cigno grigio dei mercati …e poi arriva l’epidemia. Che fa saltare calcoli e previsioni, tutto da rifare. Dopo aver completamente ignorato il virus per settimane, i mercati hanno abbandonato in un attimo tutto il loro eccessivo ottimismo. Appena è stato evidente che il problema non sarebbe rimasto circoscritto alla Cina, è arrivato il crollo. Un crollo senza precedenti per velocità e dimensioni. In sole due settimane i listini statunitensi si sono per esempio «mangiati» tutti i guadagni accumulati nei quattro anni di presidenza Trump. Qualcuno ha evocato il mitologico «cigno nero», ossia un evento raro, imprevisto e imprevedibile che quando si verifica stravolge ogni piano. Sarebbe però il caso di parlare al massimo di un «cigno grigio». Sulla possibilità, quasi probabilità del dilagare di un virus a livello globale, gli esperti mettono in guardia da tempo. Ci sono state «prove generali» come la Sars o l’H1N1. E ancora più prevedibile era la possibilità che il Covid 19 superasse i confini cinesi. Per qualche tempo i mercati non hanno voluto vedere quel che stava accadendo davanti ai loro occhi, confidando che se le cose fossero peggiorate, le banche centrali sarebbero di nuovo arrivate in loro soccorso. E che questo sarebbe bastato. La controffensiva, massiccia, delle banche centrali effettivamente c’è stata. Tassi ancora ridotti e acquisti di titoli di Stato e societari «illimitati». Un intervento provvidenziale ma non risolutivo. Le banche centrali, soprattutto quella europea, hanno polveri bagnate. I tassi erano già a zero o sotto lo zero, sui minimi storici. I programmi di acquisto titoli sono stati rafforzati ma erano già in corso. Fed, Bce, Bank of England e Bank of Japan si sono spese assicurando liquidità e dollari a chi ne aveva bisogno, per scongiurare la carenza di moneta statunitense sui mercati internazionali che aveva caratterizzato il 2008. Misure che sono servite per mantenere in vita il sistema del credito ma che poco hanno potuto fare per arginare il crollo dell’attività economica. Rimangono le soluzioni estreme, più suggestive che efficaci. Tra queste il cosiddetto «Helicopter Money», l’elicottero che dall’alto lancia denaro sulla gente. La metafora indica una tecnica d’intervento delle banche centrali in cui il denaro di nuova creazione non viene immesso nel sistema economico attraverso banche ma «regalato» direttamente a cittadine e aziende. Troppo bello per essere vero? Sì. È una misura che può avere una qualche utilità come terapia d’urto per un periodo molto limitato. Soprattutto in un momento in cui aziende, anche sane, vedono azzerarsi i ricavi ma devono continuare a pagare stipendi e fornitori. Se prolungata nel tempo tende a neutralizzarsi da sola. L’aumento di denaro disponibile provoca inflazione, i prezzi salgono e anche se le persone hanno ricevuto i soldi non è detto che il loro potere di acquisto sia cresciuto. Servirebbero quindi ancora più soldi che provocherebbero un ulteriore incremento dei prezzi. E così via in una spirale pericolosa. Stritolata tra un calo sia della domanda (consumi in calo) che dell’offerta (fabbriche che non producono) l’economia globale si avvia verso una delle peggiori recessioni di sempre. Le stime sono scritte sull’acqua. Destinate a essere riformulate a ogni nuova notizia, positiva o negativa, sull’evoluzione della lotta al virus. In tal caso potremmo assistere a una brusca caduta del Pil seguita da una ripresa quasi altrettanto rapida. L’impegno sempre più esteso delle banche centrali accrescerà la dipendenza dei mercati dalle autorità monetarie, un cordone ombelicale che diverrà sempre più difficile da tagliare con uno sfasamento delle normali dinamiche finanziarie. Una reazione da manuale: chi vince e chi perde Per i mercati l’ incertezza è come la kriptonite per Superman. Li indebolisce sempre di più. Non si possono più fare valutazione realistiche su quanto un’azienda potrà guadagnare in futuro e dunque non si riesce a dare un prezzo corretto alle sue azioni o obbligazioni. La situazione che si è delineata da fine febbraio è un esempio da manuale di cosa possa accadere sui mercati in una situazione di emergenza. Ci si libera subito degli investimenti più rischiosi come azioni e titoli obbligazionari a basso rating, più esposti agli andamenti dell’economia. Si vende tutto o quasi per accumulare denaro contante e fare fronte alle esigenze di liquidità o tenersi pronti a investire una volta che si riterrà che i prezzi hanno toccato il punto più basso. Nei periodi di crisi si ristabilisce prepotentemente la gerarchia dei mezzi di pagamento che tende ad appiattirsi nelle fasi di espansione. Cash is the king, il denaro è il re. E il dollaro è il re dei re. A maggior ragione nei prossimi mesi quando l’euro si avvicinerà al suo appuntamento con il destino che potrebbe causarne il disfacimento. Questa corsa al contante finisce per penalizzare quasi tutto ciò che non è denaro liquido, oro compreso. Patiscono meno quei prodotti che sono quanto di più simile esista al contante: titoli di Stato di paesi solidi come Stati Uniti e Germania. Per la prima volta nella storia un titolo di Stato decennale statunitense è sceso ben al di sotto dell’1%. Quando tutti vogliono un’obbligazione il suo valore sale, e il rapporto con gli interessi pagati (fissi in valore assoluto) cala. Eppure, in alcuni frangenti particolarmente concitati, la Federal Reserve è dovuta intervenire anche a sostegno di questo mercato. Aziende e società finanziarie, alle prese con la necessità di reperire denaro, che non arrivava più con i ricavi e neppure attraverso le banche, molto restie a prestare in questa fase per timori di fallimenti a catena, sono state costrette a vendere tutto, ma proprio tutto quello che potevano vendere. La corsa al dollaro rischia di provocare morti e feriti. In prima linea ci sono tutti quei paesi emergenti che contano molto sull’afflusso di capitali esteri per finanziare spese e investimenti. Poi le società più fragili, quelle meno affidabili, i cui bond sono appetitosi nei momenti di espansione ma marciscono pressoché all’istante nelle crisi. In particolare tutte le obbligazioni delle società dello shale oil statunitense, la nuova tecnica di estrazione del petrolio da rocce di scisto che è profittevole soltanto con quotazioni sopra i 40 dollari al barile. Il problema è che in generale questa gelata sul credito avviene in un mondo indebitato come non mai. Le Borse hanno accusato i cali più forti dal 2008. A essere colpiti per primi sono stati i titoli di aziende direttamente esposti alle conseguenze dell’epidemia e quindi azioni di compagnie aeree e di operatori turistici oltre alle aziende del lusso poiché larghe fette dei loro ricavi provengono dalla Cina. Il paese asiatico è anche la fabbrica del mondo, qui si producono gran parte dei componenti che finiscono nei nostri pc, smartphone, automobili, eccetera. Circa l’80% delle auto prodotte nel mondo hanno almeno un pezzo che arriva dalla Cina. In controtendenza si sono mossi i titoli farmaceutici e i produttori di dispositivi medici. L’eventuale messa a punto di un vaccino significa introiti per miliardi di dollari per i produttori e, in ogni caso, l’arrivo di risorse pubbliche per sviluppare il farmaco il prima possibile e l’aumento delle vendite di medicinali per sintomi collegati al virus. L’azienda giapponese Kawamoto, che produce dispositivi sanitari come le mascherine, ha decuplicato il suo valore di Borsa in meno di un mese. Materie prime e oro, il piccolo giallo del metallo giallo A risentire delle prospettive di rallentamento economico sono stati anche petrolio e materie prime in genere. Come se non bastassero gli effetti dell’emergenza sanitaria sul petrolio si è abbattuta anche la guerra dei prezzi scatenata dall’Arabia Saudita contro la Russia. Mosca si è rifiutata di ridurre la produzione per sostenere i prezzi come chiesto da altri paesi produttori. Di fronte al «niet», Riyad ha scatenato la sua ritorsione. L’Arabia può contare su costi di estrazione e raffinazione particolarmente bassi. Con un petrolio a 20 dollari al barile riesce comunque a guadagnare abbastanza per finanziare la sua spesa pubblica. Non è così per gran parte degli altri produttori, Russia compresa. Il risultato del braccio di ferro tra le due potenze del greggio ha però provocato crolli delle quotazioni mai visti prima, con flessioni del 20% in un solo giorno. Scossoni che hanno trascinato al ribasso anche i titoli delle compagnie petrolifere i cui ricavi aumentano più sale il prezzo del greggio. Tra aprile e maggio si è verificato un tale eccesso di offerta di petrolio rispetto alle richieste che il costo del barile è diventato negativo. Ossia chi doveva ricevere del greggio pagava per non farselo consegnare e quindi non sostenere i costi dello stoccaggio. Davvero strani tempi quelli in cui una materia prima per cui fino a ieri si sono combattute guerre diventa merce di cui disfarsi. Più in generale la frenata della produzione significa meno richiesta di tutte le materie prime: rame, alluminio, acciaio ecc. In questo ambiente ostile, un solo metallo è in grado di limitare le perdite: l’oro. Ha un valore industriale ormai modesto ma da sempre è considerato uno dei beni rifugio per eccellenza ed è sufficiente che le persone continuino a essere convinte che lo sia perché lo sia davvero. Eppure nella fase più acuta dei cali di Borsa anche l’oro ha iniziato a perdere valore lasciando disorientati molti osservatori. Cosa è successo al lingotto? Non è più il bene a cui affidarsi quando la paura dilaga? La risposta è articolata. Quello che è accaduto è che molti investitori che avevano contratto prestiti, dando in garanzia titoli di varia natura, hanno ricevuto le cosiddette chiamate di margine dai creditori. Ossia poiché i titoli in garanzia stavano perdendo valore, i creditori chiedevano indietro tutti o parte dei soldi. Per far fronte a queste richieste, i debitori in possesso di oro si sono messi a venderlo sul mercato per reperire il denaro da restituire. L’oro era la cosa più facile da vendere, senza incamerare perdite eccessive. Le turbolenze sono state amplificate dai rallentamenti registrati nell’attività estrattiva e nella produzione di pezzi di piccolo taglio. Dove la domanda cresceva l’offerta latitava, dove scendeva la domanda era insufficiente. Le quotazioni hanno così subito una flessione. Quindi sì, l’oro rimane un bene rifugio, ma questo non assicura sempre un guadagno nel breve termine nei momenti di crisi. Investire richiede sangue freddo, cosa fare quando le Borse crollano Prima regola: state calmi, se potete. Precipitarsi a vendere ha poco senso, soprattutto quando tutto è incerto. I mercati tendono a iper reagire nell’immediato. Cali repentini possono essere recuperati altrettanto rapidamente. Per gli investitori più accorti questi sono anzi i momenti in cui si compra, approfittando dei prezzi più bassi. Finché non si vende le perdite sono virtuali e non reali. Tuttavia non bisogna neppure chiudere gli occhi e restare immobili in attesa che tutto passi. Fermarsi e fare alcune valutazioni. Quando dovrei avere bisogno dei soldi investiti? Quanto posso permettermi di aspettare prima che le perdite vengano recuperate? Una settimana, un mese, un anno? Gli investimenti azionari sono per loro natura piuttosto rischiosi ed esposti a oscillazioni marcate. La durata dell’investimento dovrebbe mitigare questi aspetti. Cercare di distinguere quali sono i titoli che hanno subito un calo dettato da ragioni prettamente emotive e quali invece da valutazioni più approfondite. Il vero problema per chi investe o ha investito non sono tanto i cali del listino quanto la difficoltà di fare previsioni sulla durata dell’emergenza e quindi sulle dimensioni del danno. L’epidemia di Coronavirus non ha precedenti per estensione del contagio nel mondo e impatto sull’economia. Di virus partiti dalla Cina abbiamo lunga esperienza ma nel frattempo il peso della Cina sull’economia mondiale è cresciuto, oggi Pechino vale il 19% del Pil globale. E le connessioni con il resto del mondo si sono intensificate e moltiplicate. Difficile fare previsioni. Il Fondo monetario internazionale ha adottato, inizialmente, una posizione relativamente ottimista. Un impatto economico forte ma concentrato in un periodo breve e seguito da un veloce recupero dei livelli produttivi. È quello che era accaduto nel 2003 quando la Sars ridusse la crescita economica cinese di alcuni decimali nell’arco di due trimestri. Dopo le banche centrali anche i governi hanno iniziato a muoversi. Quelli ricchi con vigore. Gli Stati Uniti con un piano di sostegno all’economia da 2 mila miliardi di dollari, la Germania ha abbandonato il mito del pareggio di bilancio è ha messo sul tavolo quasi mille miliardi per interventi di varia natura. Il dramma Coronavirus potrebbe diventare il vero banco di prova per l’Unione europea. Una volta finita l’emergenza, deficit e debiti di molti paesi membri saranno saliti su livelli mai visti. Una gestione solidale di questi fardelli, sinora sempre assente, è indispensabile. In gioco c’è probabilmente la tenuta stessa dell’Unione. Letture consigliate P. Blustain, And the money kept rolling in (and out), Public­Affaires, 2006. B.M. Boghosian, Misurare la diseguaglianza in «Le Scienze 618», febbraio 2020. J.M. Chwieroth, A. Walter, The Wealth Effect: how the great expectations of the middle class have changed the politics of banking crisis, ed. Cambridge University Press, 2019. J. Coates, The hour between dog and wolf, ed. Harper Collins, 2012. R. Dalio, I principi del successo, ed. Hoepli, 2018. X. Debrun, J.D. Ostry, T. Willems, C. Wyplosz, The art of assessing public debt sustainability: relevance, simplicity, transparency, 2019. https://voxeu.org/article/art-assessing-public-debt-sustainability R. Foroohar, Makers and Takers. How Wall Street Destoryed Main Street, ed. Crown Business, 2016. J.C. Hull, Opzioni, Futures e altri derivati, ed. Pearson, 2012 (8° edizione). R. Koo, The Holy Grail of Macroeconomics, ed. John Wiley & Sons inc., 2009. N. Irwin, The Alchemists, ed. Headline Publishing Group, 2013. D. Lubin, Dance of trillions, ed. Brookings Inst., 2018. M.Mazzucato, Lo Stato Innovatore, ed. Laterza, 2014. A. Mian, A. Sufi, The house of debt, ed. University of Chicago Press, 2014. B. Milanovic, Ingiustizia globale, ed. Luiss, 2017. P. Mehrling, The New Lombard Street, ed. Princeton University Press, 2011. R. Rajan, Il terzo pilastro: la comunità dimenticata da Stato e mercati, ed. Egea, 2019. D. Rodrick, La globalizzazione intelligente, ed. Laterza, 2015. K.D. Schwager, Market Wizards, ed. Harperbusiness, 2010. N. Shaxson, The Finance Curse, ed. Vintage Digital, 2018. R.J. Shiller, Narrative Economics, ed. Princeton, 2019. M. Stigum, A. Crescenzi, Money market, ed. McGraw-Hill, 2006 (4° ed). A. Tooze, Lo Schianto, ed. Mondadori, 2018. A. Turner, Between debt and devil, ed. Princeton University Press, 2016. N. Wapshott, Keynes o Hayek?, ed. Feltrinelli, 2015. G. Zucman, La ricchezza nascosta delle nazioni, ed. add editore, 2017. Lista dei nomi e dei luoghi citati Su ciascun numero è attivo un link che porta all’occorrenza del termine. A Aerospazio Spa 1 Agenzie di rating 1, 2 Aig (American Insurance Group) 1, 2 Amazon 1 America 1 Anni Novanta 1, 2, 3, 4 Anni Ottanta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Anni Venti 1 Antico Testamento 1 Apple 1, 1 Arabia Saudita 1 Argentina 1, 2 Atene 1 B Bagehot, Walter 1, 2 Bail-in 1, 2 Banca centrale/Banche centrali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Banca nazionale svizzera 1, 2 Bank of America 1 Bank of England 1, 2, 3 Bank of Japan 1, 2 Baruch, Bernard 1 BCE (Banca centrale europea) 1, 2, 3, 4, 5 Berlino 1 Bernanke, Ben 1 Bitcoin 1, 2, 3, 4 Blockchain 1, 2 Bond 1, 2, 3, 4 Borsa 1, 2, 3, 4, 5 Bot 1 British Petroleum 1 Brulat, Paul 1 Btp 1, 2, 3 Buenos Aires 1 Buoni collaterali 1 Buyback 1 C Call options 1 Carry trade 1 Cartolarizzazione/Cartolarizzazioni 1, 2, 3 Cash flow 1 Cassandra 1 Cdo (colletaralized debt obligation) 1, 2 Cds (credit default swap) 1, 2, 3, 4 Cds «naked 1 Cile 1 Cina 1, 2, 3, 4, 5 Coates, John 1 Collateralizzazione 1 Congresso degli Stati Uniti 1 Coronavirus 1 Covid 19 1 Crisi finanziaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Cyberpunk 1 D Deauville 1 Dornbusch, Rudi 1 Draghi, Mario 1 E Ebida (earnings before interest, taxes, depreciation and ammortization) 1 Economist, The 1 Etf (Exchange-traded fund) 1 Europa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eurozona 1 ExxonMobil 1 F Facebook 1 Fannie Mae 1 Fed (Federal Reserve) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fiat 1 Finlandia 1 Finney, Hal 1 Fisher, Irvin 1 FMI (Fondo monetario internazionale) 1, 2, 3, 4, 5 Forex 1 Foroohar, Rana 1 Francia 1 Freddi Mac 1 Future/Futures 1, 2 G Garcia, Antonio 1 Gates, Bill 1 Germania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Giappone 1, 2 Globalizzazione 1, 2, 3, 4 Goldman Sachs 1, 2 Gold standard 1 Google 1 Gordon Gekko 1 Governo britannico 1 Gran Bretagna 1 Grande Depressione 1, 2 Grande Recessione 1 Grecia 1, 2 Greenspan, Alan 1, 2 H Haldane, Andrew 1 Hammurabi 1 Hayek, Friedrich Von 2 Helicopter Money 1 I India 1, 2 Infinity Qe 1 Inflazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Inghilterra 1, 2 Internet 1, 2, 3 Irs (interest rate swap) 1 Irwing, Neil 1 Isole Cayman 1 Italia 1, 2, 3, 4, 5 J JP Morgan 1, 2, 3 K Kawamoto 1 Keynes, John Maynard 1, 2 L Lehman Brothers 1 Libra 1 Lombardia 1 Lombard street 1 Londra 1 Ltcm (Long-Term Capital Management) 1 Lubin, David 1 Lussemburgo 1 M Malaysia 1 Margin call 1 Merton, Robert 1 Microsoft 1 Milanovic, Branko 1 Mol (margine operativo lordo) 1, 2 Musk, Elon 1 N Nakamoto, Satoshi 1 Napoli 1 Nasdaq 1 New York 1 Ninja (no income no job, no asset 1 Nord Europa 1 Northern Rock 1 O Obbligazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ocse 1 Olanda 1, 2 Olivetti, Adriano 1 Opzione Call 1 Opzione Put 1 Otc (over the counter) 1, 2 Overconfidence 1 P Parigi 1 Pechino 1, 2, 3 Perù 1 Pfizer 1 Pfn (posizione finanziaria netta) 1 Piazza Affari 1 Pil (prodotto interno lordo) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Portogallo 1, 2 Prodotto interno lordo italiano 21 Q Quantitative easing (Qe)/Allentamento quantitativo 1, 2, 3 R Recessione 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rendimenti dei titoli a lunga scadenza 1 Rendimenti dei titoli di stato 1 Riyad 1 Rodrick, Dani 1 Roe (return on equity) 1 Roi (return on investment) 1 Roma 1 Royal Dutch Shell 1 Russia 1, 2 S Sars 1, 2 Scholes, Myron 1 Scuola di Chicago 1, 2 Seconda guerra mondiale 1 Seicento 1 Shadow banking 1 Shale oil 1 Spagna 1, 2 Spread 1, 2, 3, 4 SPV (special purpose vehicle) 1 Stati Uniti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stiglitz, Joseph 1 Stone, Oliver 1 Subprime 1, 2, 3 Svizzera 1, 2, 3, 4 Szabo, Nick 1 T Tassi di interesse 1, 2, 3 Tax Justice Network 1 Tesla Motors 1 Tether 1 Time (magazine) 1 Tiscali 1 Titoli di Stato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Titoli obbligazionari 1, 2 Tokyo 1 Trump, Donald 1 Tufts University 1 U Ucraina 1 Unione europea 1, 2 Usa 1, 2, 3, 4, 5 Utilities 1, 2 V Venezuela 1 Vietnam 1 W Wallich, Henry C. 1 Wall Street 1, 2, 3 Washington 1, 2 Wright, Steven 1 Y Yale 1 *** Le 10 occorrenze più frequenti Lemma N. occorrenze Banca centrale/Banche centrali 23 Titoli di Stato 17 Obbligazioni 16 Stati Uniti 11 Fed (Federal Reserve) 10 Crisi finanziaria 9 Germania 8 Europa 7 Inflazione 7